
Addio a Mimmo Jodice, ha fotografato la bellezza e l’anima di Napoli e del Mediterraneo
«Non so se la bellezza salverà il mondo, ma per me è balsamo e quiete». In questa frase, pronunciata con la voce calma di chi ha passato una vita a misurare la luce, c’è tutto Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi italiani del secondo Novecento, morto all’età di 91 anni. È stato protagonista di una stagione irripetibile della fotografia italiana, quella in cui l’obiettivo non serviva solo a documentare, ma a capire, a sentire, a prendere posizione.
Dopo diversi lavori di impronta socio-antropologica sulla realtà della sua Napoli, la sua ricerca si è focalizzata sul mito antico delle civiltà mediterranee (“Isolario mediterraneo”, 2000) e sugli spazi urbani, oniricamente deprivati della presenza umana (“Città visibili”, 2006). Nato il 29 marzo 1934 a Napoli, nel Rione Sanità, figlio di un’Italia povera e indomita, Domenico ’Mimmo’ Jodice aveva imparato presto che il vedere è una forma di resistenza. La fame, l’ingiustizia, la fatica di vivere nei vicoli di Napoli furono le prime lezioni di composizione: insegnarono a guardare, e poi a raccontare, ciò che gli altri non volevano vedere. Negli anni Cinquanta si avvicina per caso alla fotografia. Non aveva studi accademici: autodidatta, curioso, mosso da una fame di immagini più che di pane.
Nei primi esperimenti degli anni Sessanta – quelli presentati da Lucio Amelio, tra i fermenti dell’arte concettuale napoletana – la fotografia diventa linguaggio puro, spazio di libertà. Collabora con Andy Warhol, Joseph Beuys, Sol LeWitt, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis: artisti che, come lui, credevano che l’arte potesse cambiare la percezione del reale. Fu allora che Jodice cominciò a pensare la fotografia come un’arte autonoma, non ancella della pittura né semplice strumento di cronaca. «Volevo che la fotografia entrasse nell’Accademia come il disegno o la scultura», raccontava. E ci riuscì: dal 1970 al 1994 insegnò fotografia all’Accademia di Belle Arti di Napoli, dove fondò la prima cattedra italiana della disciplina. Per generazioni di studenti fu maestro e compagno di cammino, uno che portava i ragazzi per strada «a educare lo sguardo alla luce», a eliminare il superfluo fino a far emergere la forma pura delle cose.
Fotografare per restituire giustizia
Ma la sua storia non è solo quella di un artista, è quella di un uomo che ha creduto nella fotografia come strumento di giustizia. Negli anni Settanta, con la moglie Angela, militante e compagna di vita, pubblica riviste come “Il cuore batte a sinistra” e “Fabbrica e città”, denunciando lo sfruttamento, lo scempio edilizio, la miseria delle periferie. Jodice fotografava «per cambiare il mondo”. Le sue immagini – i vicoli, gli operai, i bambini del colera – sono colpi di luce e di pietà, mai di retorica. Poi arrivò la delusione: “Dopo dieci anni di impegno capii che nulla stava cambiando. Mi distrusse. Per un anno non fotografai più».
Da quella crisi nacque la seconda vita di Jodice. Quando tornò a scattare, il suo sguardo si era spostato dentro di sé. “Vedute di Napoli” (1980) segna la svolta: la città appare deserta, senza uomini, sospesa in una dimensione metafisica. È la Napoli dell’attesa, «deserta, triste, angosciante, ma anche misteriosa e bellissima». Da allora, le sue fotografie diventeranno luoghi del silenzio, spazi dove il tempo si ferma per lasciare parlare la memoria. La parola “Attesa” ritorna spesso nel suo lessico. Non è rassegnazione, ma tensione: “tendere a”, come suggerisce l’etimologia latina. In quell’attendere, Jodice trovava la speranza che il mondo potesse ancora cambiare, anche solo attraverso la contemplazione. Le statue greche del ciclo “Anamnesi”, i templi di Mediterraneo, le nature morte di Eden: tutto in Jodice è movimento interiore, passaggio tra passato e presente, sogno e realtà. Ogni fotografia è un ponte invisibile tra l’uomo e ciò che resta.
Fonte: Il Sole 24 Ore
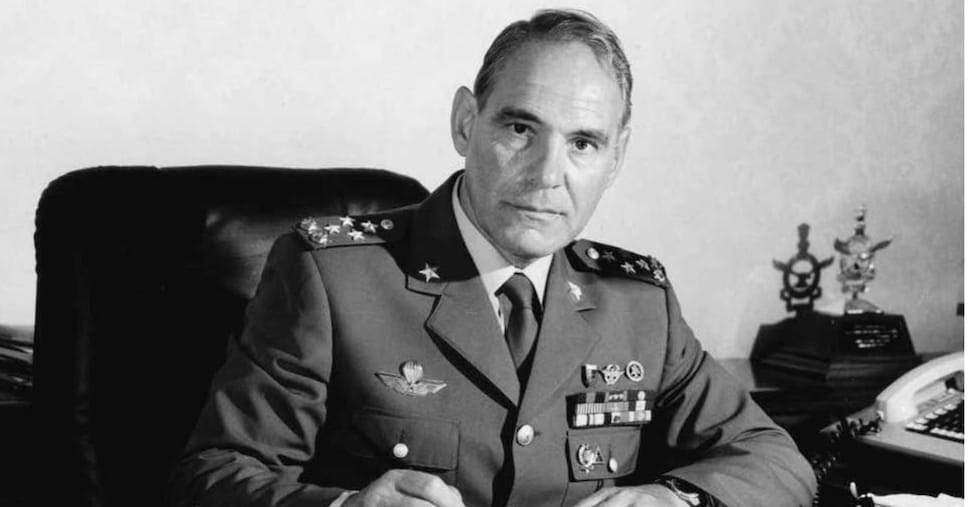


-U65678756070XiS-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpeg?r=1170x507)
