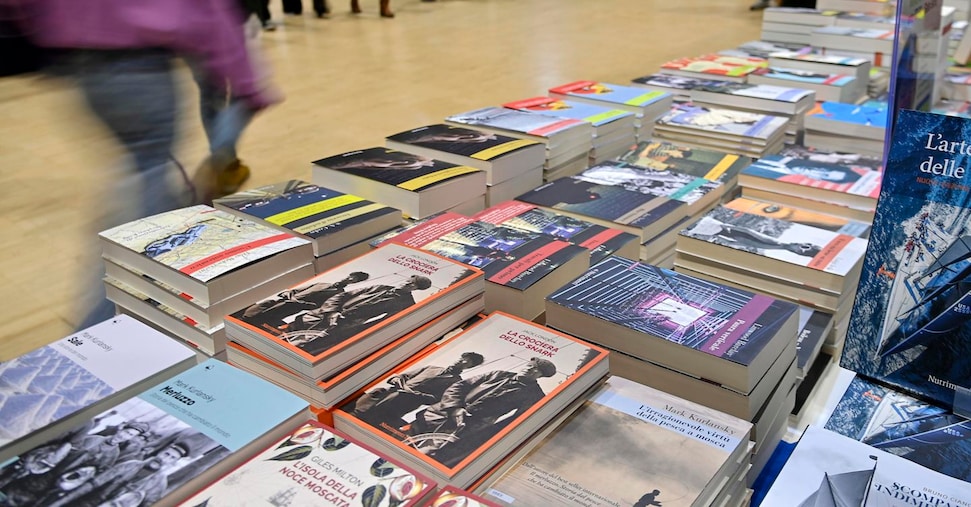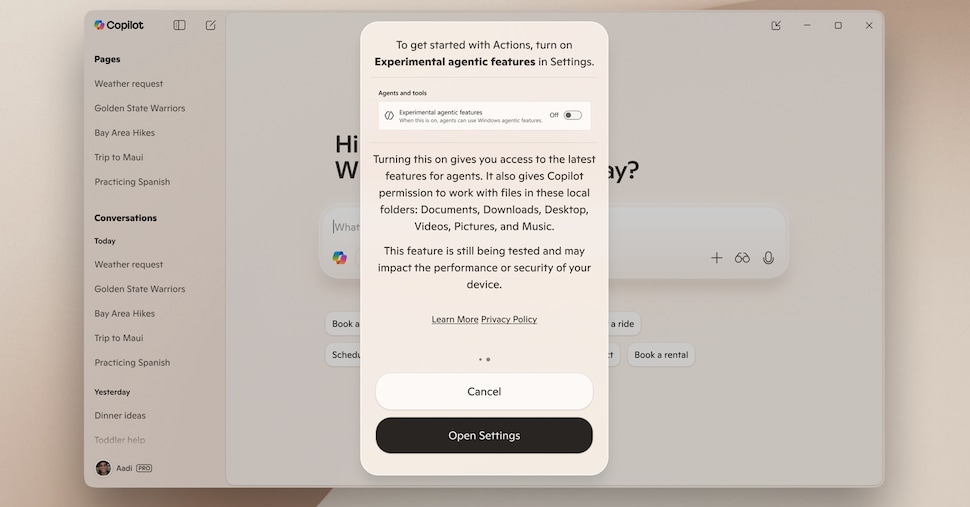Atena e le insegne dei pellegrini portano in Vaticano
Maria Luisa Colledani
Atena, elegantissima, osserva la costruzione della nave Argo e sussurra l’epopea degli Argonauti. In queste due lastre di terracotta di età giulio-claudia, c’è tutto l’equilibrio e la compostezza delle linee della classicità e il tempo eterno del mito. Nella sala della Villa Farnesina di Roma, dove sono esposte, regna il silenzio, se non fosse per il parquet che scricchiola appena sotto i piedi dei visitatori. E quel rumore è esso stesso senso del tempo e della bellezza che il banchiere senese Agostino Chigi volle per rendere magnifica la Villa, casa dell’Accademia dei Lincei e in questi mesi sede della mostra Sulle vie del Giubileo. Pellegrini, treni, papi, promossa dall’Accademia Nazionale dei Lincei, dal Gruppo FS Italiane e dalla Fondazione FS Italiane, con il sostegno della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Anas (Gruppo FS Italiane), l’Associazione Archeolog ETS e con il patrocinio dell’Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei.
La Villa Farnesina, sulla destra del Tevere, si trova nella Regio XIV Transtiberim che comprendeva Vaticano, Gianicolo e il quartiere di Trastevere, compresa l’isola Tiberina. Fra il I secolo a.C. e la prima età imperiale qui erano sorti horti sontuosi, quelli di Caligola e Nerone, di Agrippina, con spazi pubblici e di rappresentanza, un circo, il teatro, lunghi portici. Erano spazi per l’otium, poi riconvertiti alla morte di Nerone fino all’edificazione da parte di Costantino della Basilica dove, secondo la tradizione, fu sepolto Pietro, martirizzato nel circo di Caligola e Nerone. La storia, la ricchezza, la tragedia sono passate in quest’area e sono testimoniate dal rinvenimento delle due lastre – fra i pezzi più emozionanti della mostra – durante gli scavi in Piazza Pia, reimpiegate come copertura di un impianto fognario della fullonica di età flavia realizzata sul giardino porticato di Agrippina e Caligola, a ridosso del fiume.
Dopo i fasti imperiali, in età altomedievale, l’area è occupata dalla Schola Saxonum, una delle quattro scholae peregrinorum fondate a San Pietro per accogliere i pellegrini che arrivavano a Roma. I viandanti cominciano ad affollare la città, i pellegrinaggi fanno sviluppare l’arte romanica, le strade si riempiono di gente che viene da ogni dove per adorare la tomba dell’apostolo caro a Cristo e gli scavi archeologici a Palazzo de’ Penitenzieri, che la mostra valorizza al meglio, hanno restituito fra gli strati di un probabile centro manifatturiero oggetti commoventi che testimoniano il fluire della vita: 200 oggetti in osso finiti e semilavorati, resti della lavorazione di una fornace per la calce, numerose monete anglosassoni e manufatti di provenienza nordeuropea. E dagli strati della strada, databili alla metà del XIV secolo, sono tornate alla luce due chicche, due signa peregrinationis, oggetti devozionali che i viandanti portavano con sé come benedizione. Uno raffigura il Volto Santo di Lucca e l’altro la Madonna Nera di Rocamadour (Francia) a dimostrare come tutte le strade già allora portavano a Roma. Chissà che meraviglia doveva essere la città, con i suoi palazzi e le sue chiese. Dall’alto del Gianicolo, proprio poco prima di raggiungere il Vaticano, i pellegrini avevano davanti una distesa d’arte e vita infinite, come testimonia la veduta, composta da 12 fogli, realizzata da Giuseppe Vasi nel 1765, che elenca 390 siti e monumenti, quasi un Baedeker ante litteram dell’Urbe.
Fra le vie più note verso San Pietro, una delle principali era la via della Lungara, detta anche Via Sancta, a conferma della sua funzione: andava dalla Porta Settimiana, costeggiava le proprietà Farnese-Chigi – a ricordarci come Villa Farnesina è sì Raffaello, Baldassarre Peruzzi e Sebastiano del Piombo con la Loggia di Amore e Psiche e quella di Galatea, ma è anche stratificazione di epoche –, passava davanti alla chiesa di San Giacomo e quella di San Leonardo (andata distrutta), per arrivare alla Porta di Santo Spirito in Sassia (che deriva da Schola Saxonum) e, da qui, alla Basilica della cristianità. Dal Medioevo, i pellegrini hanno cambiato il volto dell’Europa e i viaggi hanno segnato il fluire del tempo. Come dimostra anche il treno di papa Pio IX (1792-1878) che chiude, quasi fosse un fuoco d’artificio, la mostra. I moti del ’48 avevano obbligato il pontefice a rifugiarsi a Gaeta e il viaggio in treno da Portici a Pagani aveva segnato la sua curiosità per il nuovo mezzo. Era un cavallo di fuoco diabolico o una nuova opportunità? Stava di sicuro entrando nell’arte e Raffaele Faccioli, Luigi Selvatico e Anselmo Bucci si fanno stregare dalle penombre delle stazioni, dalle fatiche dei passeggeri. Nello Stato Pontificio sono inaugurate la Roma-Frascati, la Roma-Civitavecchia, la Roma-Velletri-Ceprano e la Roma-Ancona-Bologna per qualche centinaio di chilometri e Pio IX la prendeva con filosofia: «C’è sempre un cammino da compiere e una luce da seguire».
Fonte: Il Sole 24 Ore