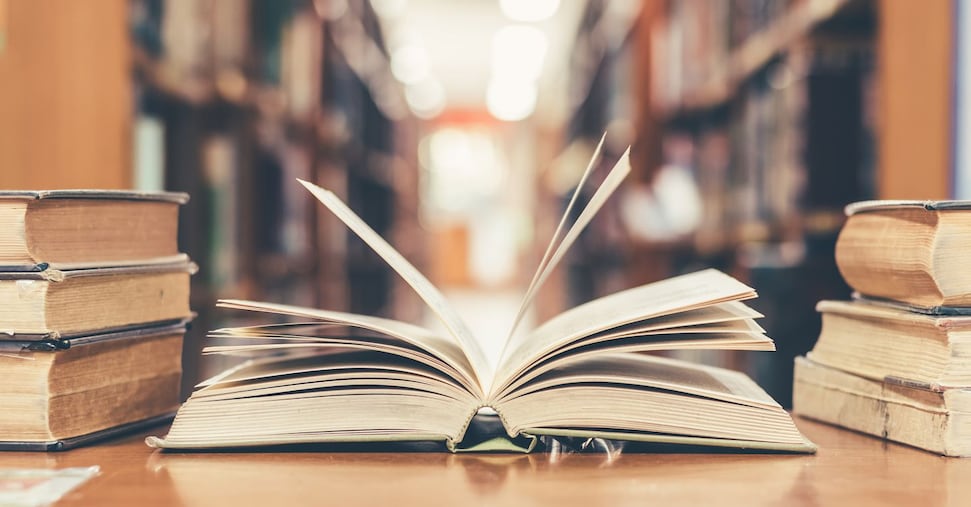Canziani: parte di un racconto più ampio che travalica i confini nazionali
Cecilia Canziani, romana classe 1976, storica dell’arte, curatrice, docente di Fenomenologia dell’Arte Contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila, è co-fondatrice del centro di ricerca sull’arte conteporanea IUNO. Tra i progetti espositivi indipendenti più rilevanti da lei curati nel 2023 «Roma, a portrait» a Palazzo delle Esposizioni, «Una felice corsa» alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna a Bologna; nel 2022 «Sara Basta. La prima madre» alla Fondazione Pastificio Cerere di Roma e nel 2021 «Io dico io» alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma.
Ci racconti di te, del tuo percorso e della tua visione curatoriale? Soprattutto quali mostre che per impatto ed importanza possono essere qualificanti del tuo percorso?
Sono una figura ibrida: mi sono formata come storica dell’arte e parallelamente come curatrice studiando a Roma, Siena e Napoli e Londra, da sempre affiancando alla ricerca il fare. Curare mostre è stato il mio modo per dare forma tangibile ai pensieri, e insegnare in Accademia – oggi – è un modo per pensare ad alta voce insieme ad altre persone cose che a volte diventano esposizioni o testi. Ho lavorato come curatrice indipendente, come direttrice di una Fondazione, come coordinatrice di un Master di Arts Management; ho fondato due spazi indipendenti e una casa editrice, sempre insieme ad altre persone: credo nello scambio e nella forza delle relazioni. Mi piacciono i rapporti di lunga durata con colleghi, con artisti e anche con le istituzioni: i dialoghi che durano nel tempo e fanno crescere insieme. Tra i progetti recenti identitari: IUNO, che ho fondato con Ilaria Gianni; «Io dico io», mostra voluta da Cristiana Collu alla Galleria Nazionale che ho curato con Lara Conte e Paola Ugolini e Roma, a «Portrait», prima edizione del festival delle Accademie e Istituti di Cultura stranieri che mi ha permesso di raccontare a Palazzo delle Esposizioni la storia del dialogo vivo dall’Ottocento a oggi tra la città e le comunità artistiche internazionali. E la soddisfazione di esporre un quadro di Corot. Andando indietro nel tempo citerei la fondazione Nomas e ZegnArt, un progetto internazionale di arte pubblica e collezione diffusa costruito attraverso un tavolo di lavoro che comprendeva noi curatori – oltre a me, Simone Menegoi e Andrea Zegna – e l’azienda.
Guardando al passato c’è un Padiglione Italia che ti ha particolarmente colpito o ispirato e quali errori non vanno ripetuti? E ampliando lo sguardo a quelli internazionali?
Ho sempre guardato con attenzione e ammirazione al lavoro fatto da tutti gli artisti e curatori che hanno lavorato al Padiglione Italia. Se devo indicare una predilizione direi che il padiglione di Massimo Bartolini curato da Luca Cerizza e «Il mondo magico» con Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi e Adelita Husni-Bey, curata da Cecilia Alemani, rappresentano due esempi diversi ma capaci di comunicare in maniera immediata, lasciando parlare le opere e usando in maniera egregia lo spazio senza farsi intimorire dalle sue proporzioni. Tra i padiglioni internazionali ho amato moltissimo Wael Shawky per quello Egizio, Archie Moore e Marco Fusinato per il Padiglione Australiano; indimenticabile Anne Imhof al Padiglione Tedesco; indietro nel tempo Ragnar Kjartansson per il Padiglione Islandese; Markus Schinwald al Padiglione Austriaco e Steve Mc Queen al Padiglione della Gran Bretagna.
Fonte: Il Sole 24 Ore
-U38350780661Dtt-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpg?r=1170x507)