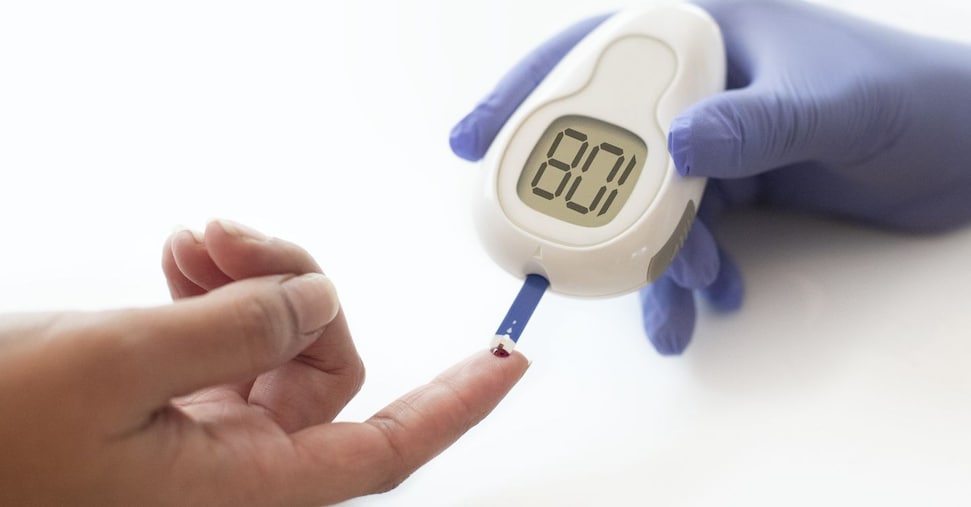«Chimica, con dazi al 30% mercato americano inaccessibile»
«Se i dazi venissero confermati al 30%, per diversi prodotti chimici il mercato americano diventerebbe di fatto inaccessibile». Il presidente di Federchimica, Francesco Buzzella, traccia una prospettiva molto critica sull’impatto delle tariffe di Trump che sono diventate una delle principali preoccupazioni degli imprenditori. Siamo in una fase in cui costi esogeni, come i dazi e i conflitti, ed endogeni, come l’energia e lo tsunami normativo, stanno minando la competitività dell’industria chimica europea ed anche italiana. I numeri parlano chiaro. Quelli di Federchimica dicono che «il settore, in Italia, dal 2021, ha perso l’11% del valore della produzione. E il 2025 chiuderà ancora in negativo, con un – 1,5% dopo i numeri negativi degli ultimi 3 anni». Proprio ieri Buzzella ha incontrato gli imprenditori, dopo aver scelto di dedicare uno spazio specifico all’assemblea privata, che si è svolta separatamente da quella pubblica (si terrà il 27 ottobre) per dedicare maggiore ascolto e avere un confronto con gli associati, anche per capire le criticità e avere input e suggerimenti da implementare.
La valutazione
Oggi una valutazione puntuale dell’impatto dei dazi americani sulla chimica «non è possibile a causa di un quadro così mutevole e flessibile nel tempo. Per la chimica l’export supera i 40 miliardi di euro e gli Usa sono il quarto mercato di destinazione, con quasi 3 miliardi. L’impatto non riguarda solo il prodotto chimico, ma tutta la manifattura europea. Senza l’esportazione di manufatti europei anche la chimica che contribuisce alla loro produzione verrà penalizzata. Oltretutto è concreto il rischio che Paesi come la Cina non riescano più a esportare negli Stati Uniti e dirottino tutto verso l’Europa. In questo modo saremmo doppiamente danneggiati: un riorientamento dei prodotti cinesi verso il mercato europeo aggraverebbe la già forte pressione competitiva. Tra il 2021 e il 2024 la quota cinese sull’import italiano di chimica è già passata dal 6 al 16% e, nei primi quattro mesi del 2025, tali importazioni sono aumentate di un ulteriore 24%».
La geografia produttiva
All’orizzonte il rischio che i dazi americani spostino produzioni dall’Italia è abbastanza limitato perché «la maggior parte delle nostre associate sono Pmi, molto radicate in Italia – ragiona Buzzella -. Il fattore dazi però spingerà qualche azienda, soprattutto quelle più grandi e le multinazionali, a guardare sempre più verso gli Stati Uniti e a investire per produrre là». In generale la geografia della produzione sta cambiando il suo baricentro. «Dal 2021, la produzione chimica cinese è aumentata del 26% a fronte di una domanda mondiale in espansione del 9%. Nello stesso periodo, gli Usa hanno limitato la crescita al 3% e l’Ue ha perso il 12% (-11% in Italia) – dice Buzzella -. Un trend confermato già nei primi quattro mesi del 2025: nonostante un anticipo cautelativo degli acquisti per anticipare i dazi la produzione chimica ha segnato un calo pari allo 0,4% su base annua, in significativo deterioramento nei mesi più recenti. Tutto ciò avviene dopo un 2024 deludente nel quale alla significativa contrazione del 2022-2023 ha fatto seguito una seppur lieve flessione. La crisi energetica, pur avendo superato la sua fase più acuta, continua a condizionare il settore, comportando un deterioramento del saldo commerciale che, nei primi mesi del 2025, è tornato ad aggravarsi».
Le previsioni
Se il quadro dell’industria chimica non è semplice, questa debolezza non caratterizza solo l’Italia ma coinvolge l’Europa, con un andamento in Germania – primo produttore europeo – persino più penalizzante (-19%). L’Italia soffre un po’ meno di altri Paesi europei, con un -11%, grazie anche alla minore quota di chimica di base che è quella più energivora ed esposta a situazioni di sovraccapacità a livello internazionale. Sulla chimica di base sono stati persi molti impianti in Europa, ma anche in Italia, a causa di costi energetici e delle materie prime molto alti e di regolamentazione. «Nel contempo stiamo assistendo a un aumento importante di prodotti chimici che arrivano dall’Asia e dalla Cina in particolare. Si è creata un’asimmetria competitiva per cui la nostra industria ha costi energetici più alti, sistemi legati alle emissioni e deve pagare anche per i gas combusti. Draghi, nel suo rapporto, ha messo in luce che in Europa rischiamo una deindustrializzazione pesante», afferma Buzzella. L’Italia riesce però a contenere il rallentamento anche perché la quota di produzione di chimica fine e di specialità rappresenta il 55%, mentre a livello europeo è in media il 37%. Al contrario, dal 2021 la produzione chimica cinese è aumentata del 26% a fronte di una domanda mondiale in espansione del 9%. Nello stesso periodo gli Stati Uniti hanno limitato la crescita al 3% e la Ue ha perso il 12%. Il Cefic, il consiglio europeo dell’industria chimica, prospetta dati molto preoccupanti. Prevede che di questo passo si rischi di arrivare alla chiusura di 300 siti e alla perdita di 200mila posti di lavoro nei prossimi 3/5 anni a causa di un quadro normativo che non aiuta l’industria.
Le preoccupazioni delle imprese
In questo contesto tra le preoccupazioni maggiori delle imprese ci sono anche «i costi dell’energia, che è alla base della competitività di tutto il sistema e riguarda le aziende, ma anche le famiglie. «Avere energia a basso costo è un boost inimmaginabile per tutta l’economia e, del resto, era uno dei capisaldi del piano Mattei, nel secondo dopoguerra – ricorda Buzzella -. La chimica è tra i settori più sensibili al costo dell’energia in quanto utilizza le fonti fossili sia a fini energetici sia come materie prime. Le nostre imprese negli ultimi anni stanno sostenendo costi energetici nettamente superiori a quelli dei nostri principali competitor. Per l’Italia l’aspetto di maggiore penalizzazione risiede nel costo dell’elettricità, più alto anche rispetto ai principali Paesi europei. Nel primo semestre 2025 il prezzo medio all’ingrosso è risultato di 120 euro/MWh a fronte dei 60 circa di Francia e Spagna. Negli Stati Uniti, poi, lo scarto è ancora più grande. In Europa il gas viene scambiato a 42 euro a Mwh contro i 13 dollari degli Usa. I costi energetici, poi, sono ulteriormente appesantiti dalle politiche climatiche europee». Complessivamente questo significa che «tra costi diretti e indiretti per le emissioni di CO2, la chimica versa in un anno oltre 600 milioni di euro, un onere prossimo a tutte le spese di R&S del settore che non grava sui produttori extra-europei. In uno scenario al 2030 il costo complessivo potrebbe raddoppiare, arrivando a superare 1,5 miliardi di euro», calcola Buzzella.
Fonte: Il Sole 24 Ore