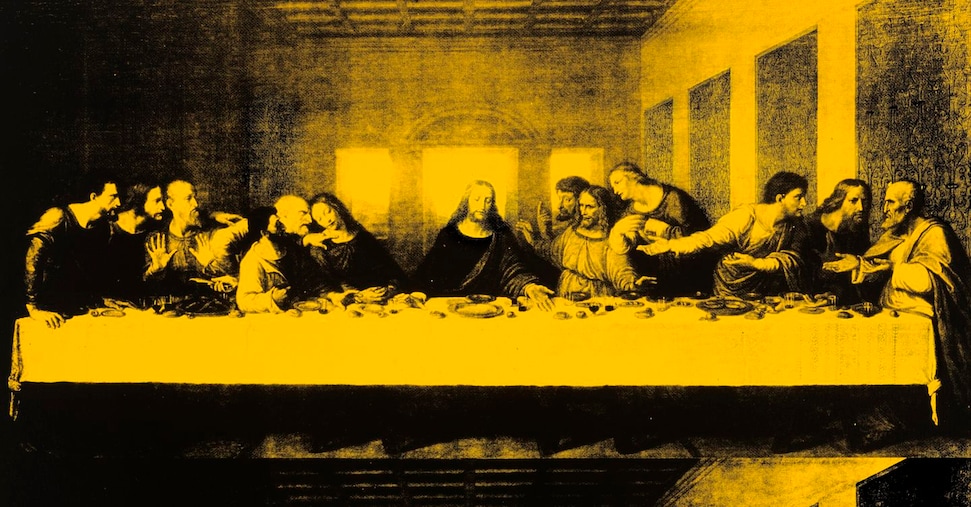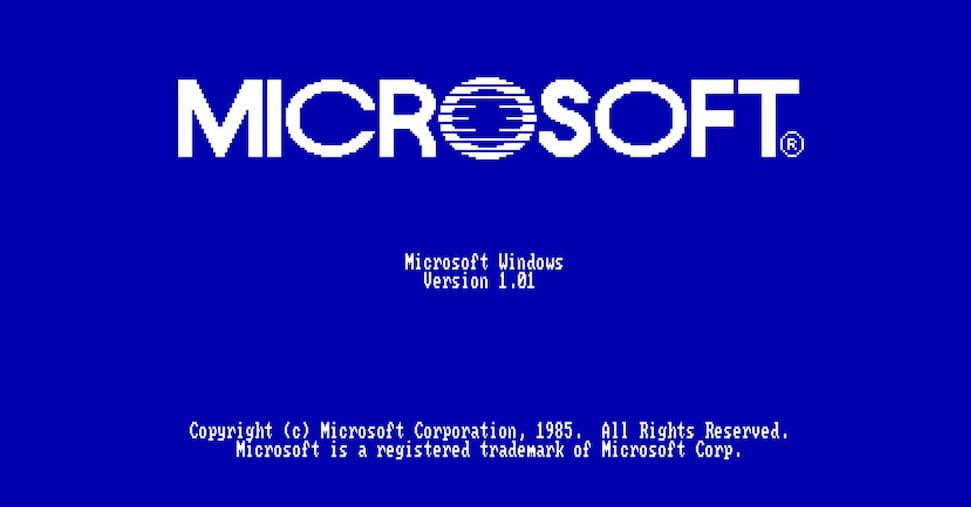Città a 30 km orari, risparmi per 150 milioni in sei mesi
Ridurre la velocità funziona. Almeno secondo le valutazioni raccolte dal 22° Rapporto Audimob Isfort sull’esperienza di Bologna, la prima grande città italiana ad applicare in modo organico il limite dei 30 km/h. L’avevano ribattezzata “città 30” con un esperimento lanciato dal Comune di Bologna il 16 gennaio del 2024: in ampie zone della città la velocità massima consentita dai veicoli è stata abbassata di 20 km/h, dai vecchi 50 a 30 appunto. Oggi a quasi 12 mesi di distanza il centro studi sui trasporti traccia una linea. E indica frenate brusche dimezzate, accelerazioni anomale in calo di un terzo, emissioni ridotte fino al 17% e tempi di percorrenza sostanzialmente invariati: meno di 30 secondi in più per tragitti di dieci minuti. Un insieme di effetti che, nelle stime, si traduce in oltre 150 milioni di euro di costi sociali evitati in sei mesi tra collisioni, feriti e situazioni di rischio.
Il quadro internazionale: città lente e quartieri più vivi
Le analisi di Isfort collocano le “Zone 30” dentro una tendenza internazionale che sta modificando l’uso dello spazio urbano. Barcellona con le “superillas”, Parigi con la “ville du quart d’heure”, Londra con la strategia “Healthy Streets”: modelli diversi, ma convergenti nel ridurre la velocità media, restituire centralità ai quartieri, accorciare gli spostamenti quotidiani. È un disegno che comprende sensi di marcia ripensati, corsie ciclabili e del Tpl, arredo urbano, parcheggi riorganizzati e interventi di urbanismo tattico. Le prime valutazioni europee indicano benefici su sicurezza, rumore e inquinamento, senza stravolgere i tempi di viaggio. Città a misura d’uomo, anche di pedone. Nel Rapporto Audimob le Zone 30 si intrecciano con la “Vision Zero”, l’impianto europeo recepito dal Piano nazionale della sicurezza stradale 2030 che punta a dimezzare morti e feriti entro cinque anni e azzerare le vittime al 2050. La riduzione della velocità è una delle leve del modello “safe system”, che non si limita ai limiti di velocità ma include infrastrutture, educazione, controlli, protezione degli utenti più vulnerabili e una diversa organizzazione dello spazio urbano. È un approccio che richiede interventi coordinati e continui, con traguardi intermedi fissati già per il 2027.
Città italiane: Bologna apripista, altre in arrivo
Per Isfort, Bologna rappresenta oggi l’esperienza più avanzata, seguita dalle sperimentazioni di Olbia, Cesena e da interventi circoscritti in città come Milano, Roma e Torino. I risultati bolognesi – emissioni in calo, traffico più uniforme, drastica riduzione delle manovre rischiose – stanno spingendo altri comuni (Firenze, Bergamo) a valutare un’estensione strutturale dei 30 km/h in attesa di un quadro normativo nazionale più organico, sul modello di Spagna e Grecia.
Il dominio dell’automobile
Ma certo il contesto italiano ancora arranca. E l’auto resta il baricentro della mobilità: nel primo semestre 2025 assorbe ancora il 60,8% degli spostamenti, nonostante un leggero arretramento rispetto al 2023. È un dominio che pesa anche sull’intermodalità, ferma al 2,8%, lontana dal 6,5% registrato nel 2019 e oggi sostenuta quasi esclusivamente dagli studenti. Il Rapporto segnala come la mancanza di alternative credibili – in particolare nelle fasce esterne delle città e nel Sud – mantenga l’Italia dentro un modello rigido, dove l’auto è indispensabile anche per tragitti brevi: l’81% degli spostamenti avviene entro i dieci chilometri e il 73% resta dentro i confini comunali. A questo si aggiunge un paradosso strutturale: auto vecchie, costose, spesso ferme per oltre il 95% del tempo eppure impossibili da sostituire per le famiglie con meno risorse. In questo quadro, l’intermodalità non decolla perché non trova l’infrastruttura per farlo. L’Italia, sintetizza Isfort, si muove su distanze da città compatta con un sistema da città dispersa.
Costi: la variabile che pesa più della velocità
Il Rapporto Audimob-Isfort richiama anche il nodo dei costi, che resta il vero punto critico della mobilità italiana. L’auto continua a essere il mezzo più utilizzato ma anche il più oneroso: 334 euro al mese per famiglia, 105 miliardi l’anno di spesa complessiva (+14,5% nel periodo 2020-2024). Un parco circolante che invecchia, resta fermo per oltre il 95% del tempo ed è sempre più caro da mantenere.
Fonte: Il Sole 24 Ore