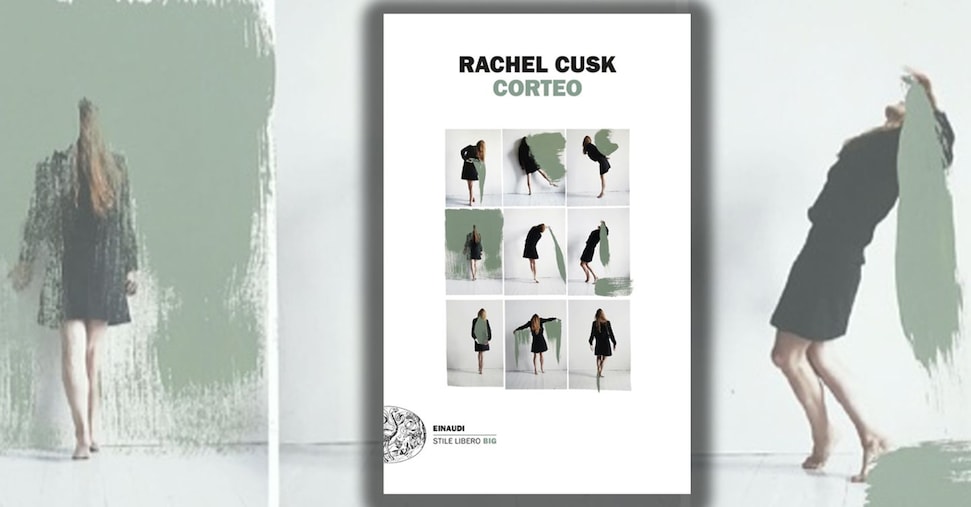
Esplorare la «long form» con un non-romanzo
Se riesco a nominare una cosa la rendo più reale? La faccio esistere? E per opposizione, oggettivandola, esisto anche io? In Corteo, l’ultimo non-romanzo di Rachel Cusk, troviamo un’artista, G, che «non vuole immaginare – vuole nominare». E poi un altro artista, si chiama G anche lui, i cui dipinti riescono «a portare alla luce una conoscenza che chi guardava già possedeva». Quanto l’esperienza è necessaria per l’estasi estetica? ci si trova a domandarsi, mentre stiamo già per leggere – proseguendo come se fosse sempre la stessa storia, ma con una visione d’insieme che continuamente si sottrae, invogliandoci ad inseguirla – le vicende di altri artisti G, che capiamo non essere la stessa persona solo perché cambia il numero di figli, il colore della pelle, gli anni in cui hanno vissuto, il sesso.
C’è il G maschio dominante che a un certo punto della vita si è messo a dipingere immagini capovolte, c’è la femmina G, che si sente artista solo comportandosi come un uomo, e ancora un’artista G del XIX secolo che ritrasse il suo corpo rigonfiato dalla gravidanza, poco prima di morire, e poi l’artista nero G, che dipinse un piccolo quadro di una grande cattedrale, un’osservazione sulla marginalità, secondo la spettatrice che lo guarda. E ancora un regista G, che riesce a esprimere la sua arte e sé stesso solo nascondendosi dietro la cinepresa e uno pseudonimo. Infine la pittrice G che si domanda se l’essere madre influenzi positivamente o negativamente la sua opera («Le sue capacità visive erano raddoppiate, da quando vi si è aggiunta la prospettiva della bambina», da quando guardava per due).
Così come, nel testo, il pubblico si aspetta dal regista G «che uno storyteller sfrutti la propria maestria e controllo per sciogliere la contorta ambiguità del reale, non che l’accentui», così, chi lo legge, si trova destabilizzato davanti all’originale narrazione di Cusk. Anziché tracciare una trama, si diverte a sbriciolarne frammenti qua e là, lasciando solo indizi da collegare tra loro per creare un senso, come in quei giochi per bambini dove unendo i puntini appare un’immagine. Un senso che quando emerge è tanto potente e appagante quanto incerto, perché l’immaginazione è stata attiva nel costruirlo, non meramente passiva. Un senso che non possiamo credere oggettivo, come non sembra esserlo quello che i personaggi trovano nelle opere d’arte viste, o anche in eventi traumatici della vita: pare più una continuazione del loro pensiero, una risposta a domande che li assillano, qualcosa che dia più senso alla loro vita.
Corteo è un vorticoso e caotico, ma sapiente, sregolamento della razionalità (secondo la narratrice, il potere della verità «risiede interamente nell’atto percettivo») nel suo girare intorno ad alcuni dilemmi, tornando a scene simboliche, o anche solo al nome G, che pare far convergere in sé tutte le varie sfaccettature di quel magmatico organismo chiamato artista (o anche semplicemente donna, o uomo). Un non-romanzo che è specchio del nostro tempo, che rifiuta, o si arrende, all’impossibilità di unità e organicità, divenendone emblema. Avvincente per la capacità dell’autrice di seminare questo percorso di serrate, seppur slegate, illuminazioni. Scaturiscono da asciutti e pregnanti paragrafi che la splendida traduzione di Anna Nadotti e Isabella Pasqualetto è capace di rendere senza perdere l’agilità del giro di frase. La narrazione tradizionale viene ulteriormente smantellata da Cusk attraverso un flusso in cui diverse coscienze si accavallano, lasciando pure spazio a narratori eterodiegetici. Coscienze di personaggi che talvolta ricordano artisti realmente esistiti, come Louise Bourgeois, con i suoi ragni neri, «forme gigantesche in equilibrio su zampe a stiletto». Forme la cui infermità «sembrava richiamare la peculiare infermità del corpo femminile. Mostruoso e umile, incessantemente all’opera». Il corpo condanna il ragno all’utilità, diventa simbolico, rappresenta «tutto ciò che nella femminilità viene negato o represso, ciò che, dietro ai vulcanici cicli di cambiamento, rimane tenebrosamente costante eppure ignoto».
Dialoghi, brandelli di vita, ecfrasi, sorprendenti descrizioni naturalistiche si susseguono generando quesiti sull’amore oblativo o su cosa sia l’arte, che può aprire gli occhi ma non necessariamente spingere ad agire. Che, come lo specchio barocco che troviamo in uno dei capitoli del libro, è così grande da riflettere chi ci si guarda non come centro dell’immagine ma come parte di una scena più vasta, permettendogli di vedersi in proporzione alle cose. Un’arte sempre in equilibrio sul crinale del senso, che può permettere di guardare molto lontano, ma da cui si può anche facilmente scivolare nel nulla, nella banalità, nella stupidità, nel conformismo sociale (che Cusk non manca di descrivere con sottile, ambigua ironia).
Fonte: Il Sole 24 Ore





