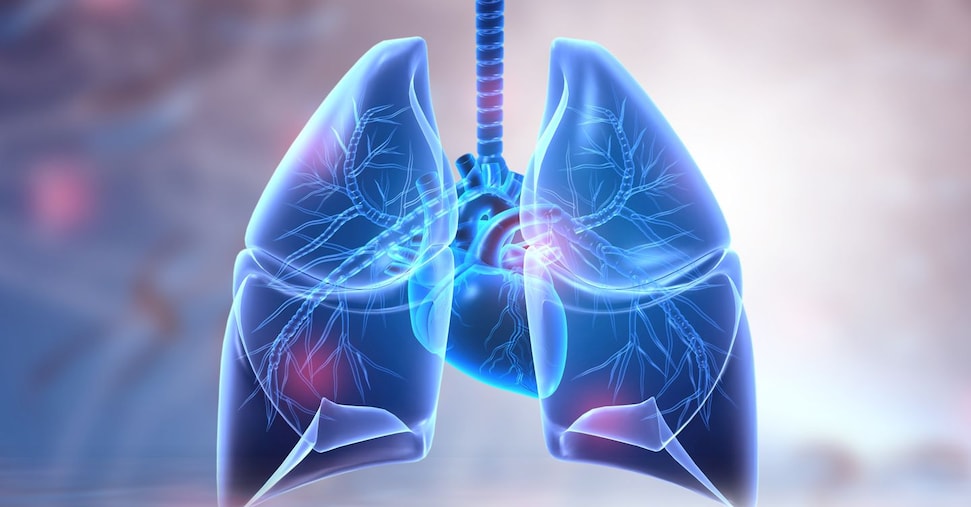I dazi Usa mettono in crisi il tessile del Lesotho, che dichiara due anni di emergenza nazionale
È come un’isola, ma di terra. Il piccolo regno del Lesotho – la sua superficie è di 30.355 km quadrati, circa come quella del Belgio – è avvolta dal Sud Africa ed è una delle tre monarchie africane insieme a Marocco ed eSwatini, l’ex Swaziland. Si inerpica sui Monti dei Draghi e i suoi 2,3 milioni di abitanti si distribuiscono fra la capitale Maseru, una quindicina di città e un’infinita rete di piccoli villaggi. Paese fra i più poveri del mondo, con un reddito pro capite di appena 1.106 dollari nel 2024, vanta però un’alta spesa pubblica in istruzione, pari a circa il 7% del bilancio statale, e uno dei più alti tassi di alfabetizzazione, soprattutto femminile, del continente. Tuttavia, altre percentuali lo rendono problematico e fragile. Secondo Oxford Economics, il 90% dell’export manifatturiero del Lesotho è generato dai prodotti tessili, cifra che lo rende uno dei primi Paesi-fabbrica di vestiti del mondo – come Bangladesh e Vietnam – dove impera la formula del “CMT”, acronimo di “Cut, Make, Trim” (Taglia, Crea, Rifinisci).
Le manifatture di abbigliamento sono il primo datore di lavoro privato del Paese, nel quale sono impiegate circa 40mila persone, sottratte all’enorme numero di chi vive sotto la soglia di povertà. I prodotti che confezionano vanno da 25 anni e per il 40% negli Stati Uniti, grazie all’accordo African Growth and Opportunity Act, che dal 2000 favorisce le relazioni commerciali fra Stati Uniti e Paesi dell’Africa Sub-Sahariana, con dazi ridotti o azzerati. I settori ai quali erano concessi i più ingenti benefici erano stati proprio il tessile e l’abbigliamento. Ma i nuovi dazi imposti dall’amministrazione Trump stanno mettendo a repentaglio la stabilità sociale del Paese, che lo scorso luglio ha dichiarato due anni di emergenza nazionale.
In marzo, al suo discorso al Congresso, Trump aveva giustificato i suoi tagli ai finanziamenti dei progetti umanitari in Africa giustificando la loro destinazione anche a «una nazione di cui nessuno ha mai sentito parlare», cioè proprio il Lesotho. Poi, nella sua dichiarazione-show alla Casa Bianca nel “Liberation Day” di aprile, sempre Trump aveva associato la cifra “50” alle nuove tariffe imposte alle importazioni dal Lesotho, la percentuale più alta di tutti i Paesi in relazioni commerciali con gli Stati Uniti (reazione a un riportato 99% di dazi imposti agli Usa). Era bastato quell’annuncio a far crollare gli ordini dei marchi statunitensi (fra cui Walmart, Levi’s e JC Penney) alle fabbriche del Lesotho, che si sono così trovate ad affrontare il blocco della produzione come ai tempi del Covid. E nonostante ora la tariffa applicata da Washington si sia attestata al 15%, naturale e tragica conseguenza di questo nuovo assetto è stato il taglio del personale, che ha provocato così un aumento ulteriore del tasso di disoccupazione, ormai prossimo al 30% e che colpisce soprattutto la popolazione più giovane, la più numerosa del regno. La prima industria nazionale del settore, Afri-Expo Textiles, fondata nel 2016, prima dell’annuncio dei dazi aveva programmato un piano di espansione che avrebbe coinvolto oltre 10mila persone, ma che è stato presto sostituito da un programma di tagli al personale per almeno 500 operai.
L’African Growth and Opportunity Act, firmato sotto l’amministrazione Clinton, è stato rinnovato sei volte a partire dal 2000 e la sua più recente proroga, firmata nel luglio 2015, è stata la più longeva. È stato uno strumento cruciale per favorire la crescita economica dei Paesi coinvolti, e secondo una stima ha generato 350mila posti di lavoro fra 2001 e 2011, soprattutto per le donne e soprattutto nel settore tessile. È stato anche visto come un canale di soft power degli Stati Uniti sul continente, per contrastare l’espansione cinese in Africa. Tuttavia, la sua scadenza è fissata per il prossimo 30 settembre e se non sarà rinnovato il Lesotho dovrà trovare presto soluzioni e alternative per non finire nel caos.
Intanto, come scrive Kate Bartlett sulla piattaforma indipendente Npr, folle di donne aspettano ogni mattina ai cancelli delle fabbriche nel distretto industriale di Maseru sperando di essere chiamate per lavorare. Fra le poche fabbriche a produrre ancora a pieno regime c’è Precious Garments, dalla quale escono le camicie da golf a marchio Trump. Ma anche lì, sono stati tutti avvisati: a settembre le attività potrebbero cessare.
Fonte: Il Sole 24 Ore