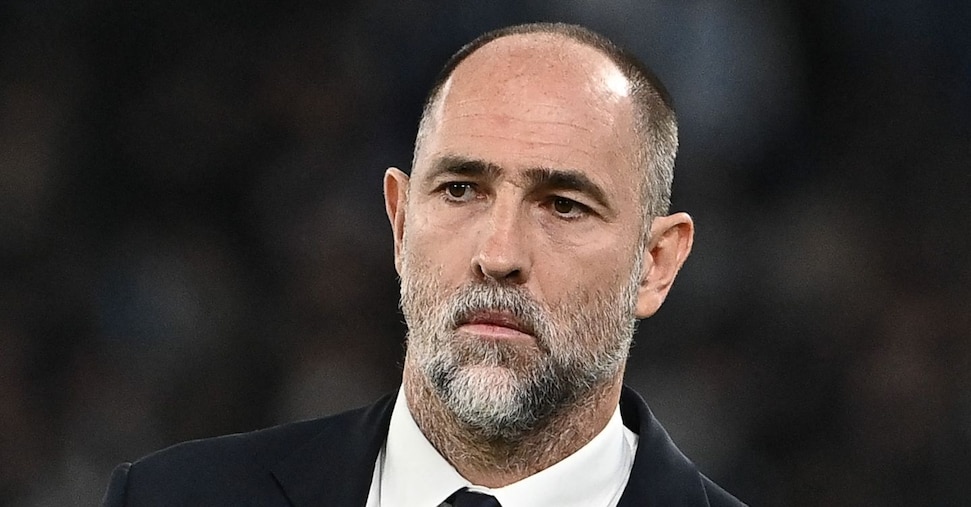I pellegrini di Santiago hanno fatto l’Europa e l’arte romanica
Tutte le strade portano a Santiago di Compostela. E da centinaia e centinaia di anni perché, secondo la leggenda, tra l’813 e l’830 fu uno sciame di stelle a guidare l’eremita Pelagio alla tomba dell’apostolo Giacomo. Una volta che le reliquie vennero dichiarate autentiche, il re delle Asturie, Alfonso II (759-842) fece costruire una prima chiesa per Santiago, sul campo della stella (campus stellae, Compostela). Da allora, milioni di uomini e donne si sono messi in cammino per pregare davanti a quella tomba piccola e doratissima. La loro è una storia di popolo e speranza, di fatica e fede che sboccia a partire dal X-XI secolo, anche perché Gerusalemme, fra sangue e crociate, era ormai troppo pericolosa per i pellegrini. Questa epopea è al centro del libro, rigoroso e poetico allo stesso tempo, I Cammini di Santiago, che lo storico Raymond Oursel (1921-2008) ha scritto una quarantina d’anni fa e che ora, con la curatela di Franco Cardini, vede una nuova pubblicazione.
Lo studioso – scrive Cardini – è «una figura leggendaria della grande medievistica francese del Novecento» ed «esplora con grande profondità la nozione di pellegrinaggio nel Medioevo occidentale soffermandosi in particolare sulla via francese per Compostela. Il pellegrinaggio, nella sua visione, non è soltanto un atto di devozione personale ma un’esperienza collettiva sociale e artistica che ha plasmato in modo duraturo il paesaggio e la cultura medievale». Così, il libro è un andare fisico verso la Galizia e anche architettonico e artistico: i pellegrini, in qualche modo, sostiene Oursel, hanno fatto il Romanico. La loro presenza, anche grazie alla protezione assicurata dai sovrani nelle zone attraversate dai viandanti, fa costruire vie, ponti, collegamenti, abbazie, ospizi. Il Camino di Santiago ha fatto il Romanico e l’Europa e Oursel è «un pellegrino dello spirito e traduce intatta, nelle sue parole, la sostanza di Cercatore di Dio».
Le vie per arrivare a Santiago erano tante: la via di Tours, quella di Saint-Gilles e Tolosa, quella di Vézelay e quella dei monti di Le Puy, amatissima ancor oggi dai francesi. Poi, certo, quella sulla quale abbiamo più riscontri è quella raccontata dalla Guida del pellegrino di Santiago, opera scritta dal chierico francese Aymericus de Picaud, probabilmente attorno all’anno 1140 e contenuta nel Liber Sancti Jacobi del Codex Calixtinus, conservato nella Cattedrale di Santiago. Per gli 800 chilometri che portano a Santiago, la Guida conta 13 tappe a cavallo (ben allenato) e circa 35-40 per un marciatore agile. A Roncisvalle inizia la Navarra, che «abbonda di pane e di vino, di latte e di bestiame», poi la Rioja, la Castiglia e Léon e la Galizia. Nelle mesetas, piatte e amletiche, le chiese romaniche paiono sproporzionate rispetto all’orizzonte; dalle mura di Astorga si domina la pianura, la cattedrale fiammeggiante, il monumentale vescovado di Gaudí, «espressione di orgoglio clericale e di inopportuna ostentazione che suscita un senso di malessere di cui ci si libera con difficoltà». Foncebadón era in rovina già allora, Villafranca del Bierzo apre le porte alla Galizia, che «trabocca di oro, argento, stoffe, pellicce di animali, dei boschi, fino ai tesori dei saraceni». A Triacastela, secondo la Guida, ogni pellegrino avrebbe dovuto «trasportare fino a Castañola (nei pressi di Santiago, ndr) una pietra per fare la calce destinata alla costruzione della basilica dell’apostolo» e, in località Labacolla, dove c’è una croce in pietra commovente, i pellegrini, dopo mesi da vagabondi affamati e nauseabondi, si lavavano tanto da confermare il versetto profetico «Ego sum vermis et non homo, opprobrium hominis et abiectio plebis».
Santiago, «città eccellentissima, ricolma di tutte le delizie, la più felice, la più eminente di tutte le Spagne», è alle viste e anche i voti da sciogliere, le preghiere. Perché, Oursel lo sottolinea, «in età romanica i pellegrinaggi sono specificatamente votivi». Poi c’è la solitudine. Eterna. Nel Medioevo, come oggi: «L’assistenza di dio e dei santi non arricchiscono l’umana solitudine; non esiste lingua più barbara». Eppure, come dieci secoli fa, si parte. Oggi è forse una moda, e i numeri lo testimoniano (nel 2025, pellegrini in aumento del 6% e a fine anno saranno superati i 500mila arrivi), ma provate a guardare le stelle, affranti dalla fatica e dalla pienezza, e solo allora, che siano i Pirenei o le mesetas, potrete vivere il verso di un canto popolare galiziano: «Una noche en el Camino, yo no la cambio por nada». Perché in quell’attimo, sopra la testa, capirete che camminare è una porta sull’infinito.
Raymond Oursel, I Cammini di Santiago, A cura di Franco Cardini, Jaca Book, pagg. 432, € 30
Fonte: Il Sole 24 Ore