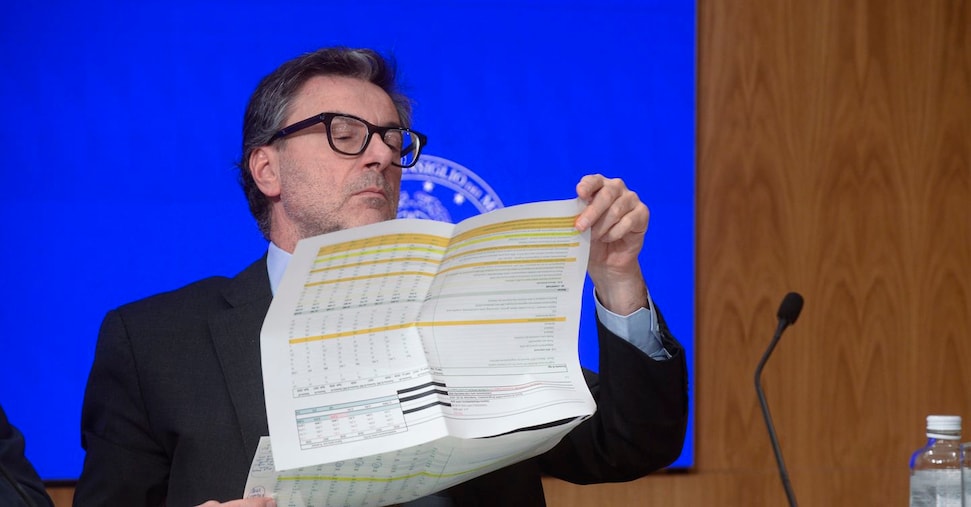Il senso di comunità e di futuro salverà le nostre montagne
La montagna è un plurale esteso, è vette come castelli, boschi di pace, pascoli a distesa ed è di tutti. Per questo Marco Albino Ferrari, gran conoscitore delle cime e delle loro dinamiche, ha scritto La montagna che vogliamo. Un manifesto. Perché la montagna è il plurale di tutti e sul quale fare progetti: «Le montagne dell’abbandono non vanno più viste con benevolenza e rassegnazione come fossero un rimorchio passivo, da assistere. No, bisogna cambiare punto di vista perché dentro quel mondo dormiente giace in potenza (a volte già espressa) un’idea di futuro pronta a fiorire. E a beneficiarne non sarà solo la montagna, ma di riflesso tutto il Paese, le pianure, le città».
Basta stare all’ombra dei tre larici millenari della Val d’Ultimo, le tre conifere più antiche d’Europa «apoteosi e glorificazione del regno vegetale che si perpetua da duemila anni» per sentire la responsabilità di un futuro altrettanto grandioso da scrivere. Quei larici, al tempo dei Romani, erano una frazione di grammo, null’altro che semi, come quelli che nascono dalle pigne conferite dalla Val di Fiemme al Centro di biodiversità di Peri (Verona). Qui estraggono i semi, compiono la disalatura, effettuano prove di germinabilità e conservano i lotti nelle celle frigo, poi, spediscono il sacchetto: 2,5 chili per quarantamila piantine di abete rosso. Il 70% dei semi diventa albero, ogni albero costa 15 euro dalla raccolta delle pigne all’affrancamento delle piantine e il ritorno economico sarà fra 80 anni. Un’eternità per la nostra società così frenetica ma, se c’è senso di comunità, come nella Magnifica Comunità di Fiemme, l’attesa è un soffio: far parte della comunità significa «sentirsi debitore per l’eredita ricevuta dal passato; ed è qui che nasce la spinta a investire nel domani». Le terre alte, che in Italia rappresentano il 50% della superficie, esulano dalle «cartoline della montagna ludica, con le piste di sci innevate, i rifugi alpini (oggi stellati), le grandi foreste dove aleggia lo spirito della wilderness come in uno spicchio di Alaska nostrano».
Le terre alte hanno bisogno di cura, di nuove cure per esprimere al meglio le loro preziose peculiarità. Servono coraggio e visione. A partire dal legno. L’Italia vanta una produzione manifatturiera del legno (per arredo ed edilizia) tra le più importanti al mondo; possiede più superficie forestale di qualsiasi altro Paese europeo; ha il tasso medio di prelievo per ettaro più basso d’Europa, e importa l’80% del materiale legnoso di cui ha bisogno. Come è possibile? Ci sono, però, esempi fulgidi di montagne piene di futuro, trainati dal senso di appartenenza che – spiega Ferrari – deve cambiare per incidere davvero: bisogna guardare a una forma ibrida e progressiva di comunità, «basata sulla ragione più che sulla tradizione. Una comunità che si legittima non attraverso il proprio fondamento tradizionale, ma nella gestione di un bene messo in comune». Un esempio è quello delle “catene” di negozietti in franchising nei piccoli paesi montani, sulla scorta di quanto avviene nello Yorkshire, in Inghilterra, o della cooperativa di comunità Valle dei Cavalieri. Si sono posti degli obiettivi: hanno trovato i fondi, per aprire il bar, poi il negozietto, il ristorante nei locali della scuola chiusa e un piccolo albergo; nel 1998, è iniziato l’allevamento di ovini e la produzione di pecorino e nel 2003 è entrato in funzione il centro visita del Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. In Francia, è comunità moderna il progetto 1000 Cafés, ne sono stati creati 221 e sono bar-caffè multiservizi nei piccoli villaggi isolati.
La montagna per vivere ha bisogno di servizi, di negozi (con il sostegno dello Stato per l’avvio), di una burocrazia su misura, che, ad esempio, faciliti le ricomposizioni fondiarie, i recuperi edilizi e scoraggi il consumo di suolo. E per disegnare il futuro delle zone montane bisogna considerarne «la specificità in continuità con ciò che le circonda, la montagna va osservata come parte di un insieme che tutto comprende. Sia nel tempo, sia nello spazio». Certo, la tecnologia è un’opzione concreta per far spostare il lavoro creativo e di innovazione in montagna, in una sorta di «delocalizzazione di prossimità». Un’altra montagna è possibile, fatta di ritorno al legno, di recupero degli immobili abbandonati, di ristrutturazioni ecocompatibili, di rigenerazione forestale grazie a piani di selvicoltura naturalistica e con l’indotto economico e ricreativo che può dare: «Non sono chimere e scenari supportati da qualche eccesso di idealità, lontani dal reale: la montagna può davvero dare risposta alle grandi trasformazioni che il nostro tempo ci impone in termini di rispetto dell’ambiente e di qualità della vita. Cogliere l’opportunità sta a noi». In fondo, 80 anni sono tantissimi o un soffio a seconda della prospettiva dalla quale li si guarda.
Marco Albino Ferrari, La montagna che vogliamo. Un manifesto, Einaudi, pagg. 144, € 13
Fonte: Il Sole 24 Ore