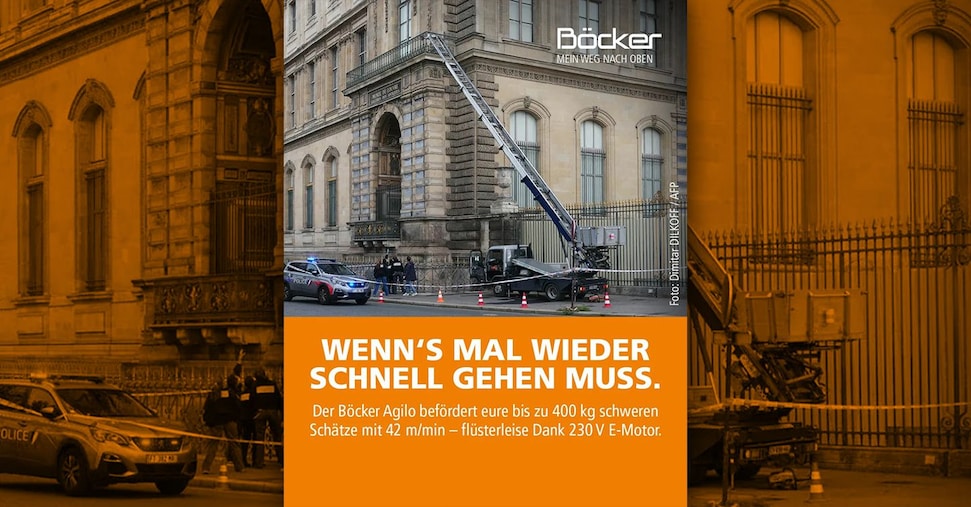Italia sempre più vulnerabile: le zone a rischio dissesto crescono del 15%
Milano sotto l’acqua del fiume Seveso, il fango a Como, il fiume Bormida esondato in Piemonte. È la cronistoria di lunedì 22 settembre in alcune aree del Paese, tre, parziali, fotogrammi di un autunno che è iniziato confermando la drammatica evidenza della fragilità del nostro territorio. Immagini che vanno in scia a un triennio, il periodo 2022- 2024, che come ricostruisce il quarto “Rapporto Ispra sul Dissesto idrogeologico in Italia” (Edizione 2024) «è stato segnato da eventi idro-meteorologici di eccezionale intensità».
Accadimenti quali «le esondazioni diffuse lungo le aste fluviali principali e secondarie nelle Marche del settembre 2022, le colate rapide di fango e detriti nell’isola di Ischia nel novembre 2022 con 12 morti, le alluvioni in Emilia-Romagna nel maggio 2023, con danni stimati in 8,6 miliardi di euro, le intense precipitazioni in Valle d’Aosta e Piemonte settentrionale nel giugno 2024», ricostruiscono i ricercatori.
Cresce il rischio frane
Il risultato è un aumento del 15% della superficie del territorio italiano pericoloso per la presenza di frane. In termini assoluti si passa dai 60.481 chilometri quadrati del 2021 ai 69.553 del 2024, che equivalgono al 23% del territorio nazionale. Più nel dettaglio le aree classificate a maggiore pericolosità (in termini tecnici «elevata P3» e «molto elevata P4») sono passate dall’8,7% al 9,5% del territorio nazionale. Gli incrementi più significativi nella Provincia Autonoma di Bolzano (+61,2%), Toscana (+52,8%), Sardegna (+29,4%), Sicilia (+20,2%). Si tratta però di un dato non necessariamente negativo dovuto invece, chiarisce il report Ispra, «a studi di maggior dettaglio effettuati dalle Autorità di bacino distrettuali e dalle Province autonome».
Ne esce così un quadro composito con due chiavi di lettura come spiega Alessandro Trigila, responsabile della Sezione Sviluppo e coordinamento dell’Inventario dei fenomeni franosi in Italia e monitoraggio in situ delle frane di Ispra. «Rispetto all’ultimo report, che si fermava al 2021, nel triennio 2022-2024 ci sono stati ulteriori studi – dice – che hanno sollecitato un miglioramento del quadro conoscitivo. Allo stesso tempo in questi tre anni ci sono stati anche tutta una serie di eventi particolarmente critici sul territorio nazionale, sia per quanto riguarda le alluvioni che le frane, che hanno determinato la modifica delle mappe di pericolosità».
Sul banco degli imputati, i ricercatori non hanno dubbi, ci sono i cambiamenti climatici che scatenano «un incremento della frequenza delle piogge intense e concentrate, con conseguente aumento delle frane superficiali, delle colate rapide di fango e detriti, delle alluvioni, incluse le flash flood (piene rapide e improvvise), amplificando il rischio con impatti anche su territori storicamente meno esposti». Un esempio? «Nel 2023 – racconta Trigila – a maggio nell’entroterra dell’Emilia-Romagna abbiamo avuto oltre 80mila frane, che sono un numero straordinariamente elevato. Basti considerare che solitamente parliamo di mille frane, al massimo 3mila, in un anno in tutta Italia».
Fonte: Il Sole 24 Ore