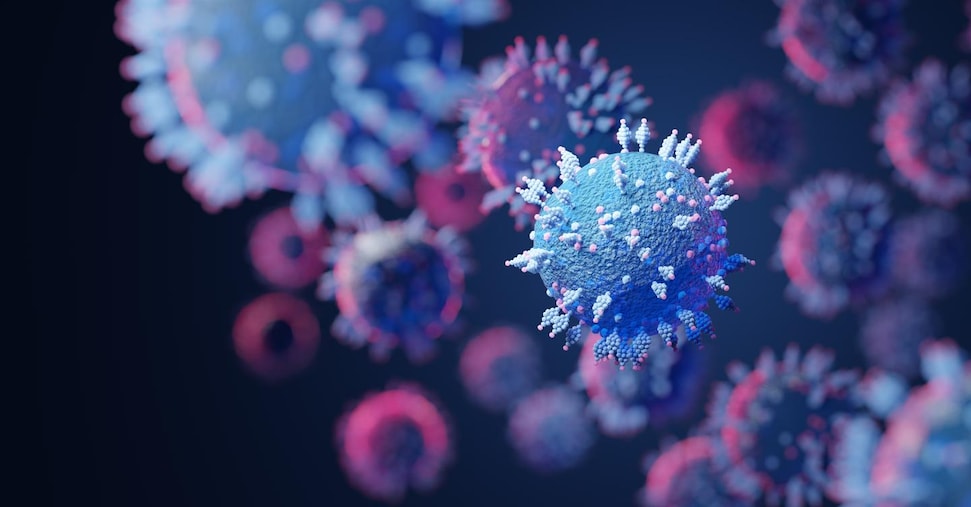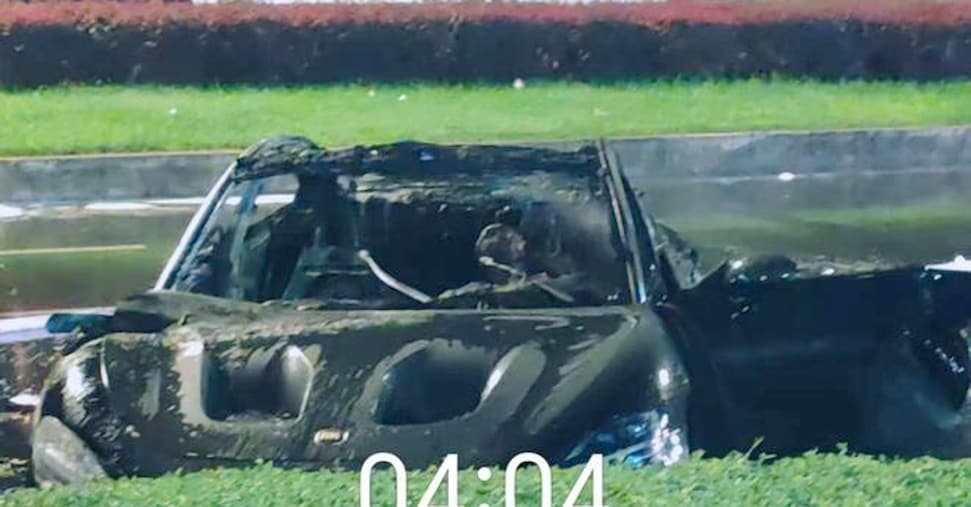La società raccontata dai numeri
La sua storia personale vale più di mille campagne per incentivare le ragazze allo studio delle materie Stem: con numeri, dati e processi statistici, infatti, Linda Laura Sabbadini è stata a suo agio da sempre grazie a una mente luminosa, la professoressa Emma Castelnuovo. Fu alle scuole medie, sotto la sua guida, che Sabbadini aveva affrontato la matematica come un gioco di intuizioni e creatività, sconfessando i peggiori stereotipi. Un approccio che ha portato con sé, negli anni a venire.
Quando è entrata all’Istat, nel 1983, lo ha fatto con un concorso destinato ai titolari della licenza media inferiore e, una volta laureata, ha pian piano scalato la montagna arrivando al vertice. La sua esperienza di vita e quella professionale si fondono nel libro Il Paese che conta: una dichiarazione di forza del valore dei numeri, della sostanza umanistica delle statistiche, della loro capacità di incidere sulla società portando alla luce fenomeni ignorati e dando visibilità a ciò che altrimenti resterebbe sepolto nel silenzio.
Lo testimonia l’esplorazione dei decenni presi in esame dall’autrice, che racconta l’evoluzione dell’Istat e i traguardi raggiunti, a cominciare dal peso finalmente attribuito alle donne, al lavoro femminile – incluso quello mai considerato tale, di cura, anche degli anziani –, alla violenza di genere sommersa dall’oscurità. Un buio spesso difensivo sotto il quale si celavano le vittime, umiliate e prostrate dalla vergogna, oltre che spaventate dall’idea di non essere credute. E non è un caso che Linda Laura Sabbadini sia riuscita a incrinare la barriera di paura e diffidenza di tante di loro attraverso le domande adeguate poste nei questionari, che rivelavano sensibilità e umanità. Ci è riuscita anche con l’esperienza maturata in sette anni di sondaggi nelle società demoscopiche, un’attività svolta da ragazza per raggranellare qualche soldo. Una tecnica, basata sull’assenza di ambiguità interpretativa, affinata con il tempo e con l’osservazione delle persone.
La formazione di chi conduce un’indagine statistica (ma anche giudiziaria, giornalistica, medica eccetera) va curata e aggiornata, per raggiungere risultati efficaci. Questi ultimi, Sabbadini lo ribadisce a più riprese, non possono prescindere dall’indipendenza dell’istituzione e dalla serietà di chi ci lavora. Le pressioni della politica o di altri attori per manipolare i dati e piegarli alle proprie idee e alla propria convenienza sono costanti (basti pensare alle sortite di Donald Trump sulle rilevazioni relative all’occupazione). Salvaguardare la terzietà, difendere l’autonomia dei numeri, blindare la trasparenza dei metodi è la precondizione per restituire la realtà e rendere un servizio al Paese.
Impossibile parlare di un libro del genere senza citarne alcuni, di numeri. Ed è difficile sceglierli nel racconto di una società che cambia pelle. Nel 1988 l’italiano ormai è la lingua dell’87% dei cittadini ma il 44,1% lo alterna al dialetto; due anni dopo arriva la prima indagine sulla disabilità, e il risultato è scioccante: un milione 151mila disabili sono ancora trattati in modo indegno di un Paese che vuol dirsi civile. Vivono infatti in uno stato di confinamento, chiusi in casa tra un divano e il letto; le donne sono 735mila sul totale. Il numero complessivo delle persone non in grado di compiere almeno una delle attività di ogni giorno (mangiare, lavarsi, vestirsi) è 3 milioni 300mila persone. Come una grande città di cui non si conosceva, prima, l’effettiva esistenza.
Fonte: Il Sole 24 Ore