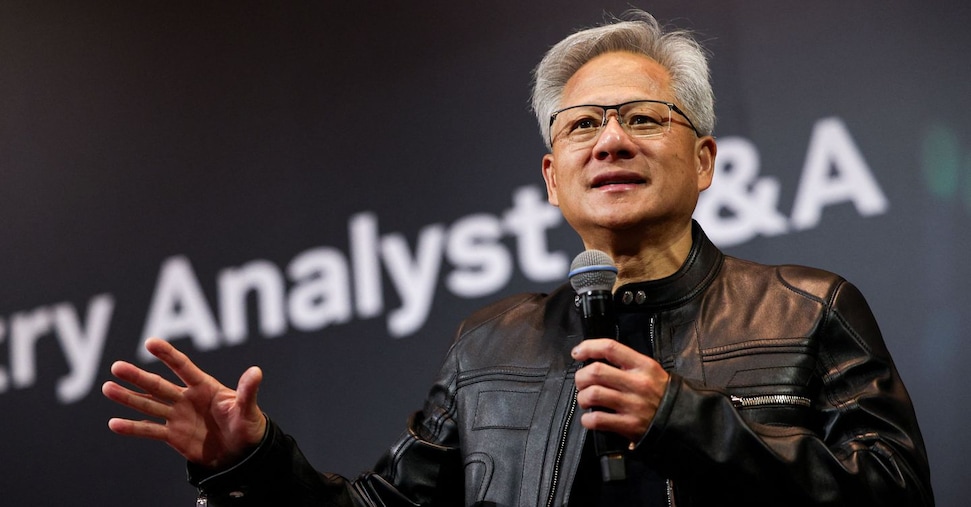L’addio alla comproprietà preclude ora possibili pretese di risarcimento
Se si considera che, nella maggior parte dei casi concreti, gli immobili “fastidiosi” non appartengono a un solo proprietario, ma (spesso per ragioni di eredità) vi è una pluralità di comproprietari che talora non vanno d’accordo oppure nemmeno si conoscono, la reale valenza della sentenza delle Sezioni unite 23093/2025 è da osservare con riguardo alla rinuncia del comproprietario alla propria quota di comproprietà.
A differenza dell’atto di rinuncia al diritto di proprietà che non è espressamente contemplato nel Codice civile (nel quale viene enunciato “solo” il principio in base al quale l’immobile vacante appartiene allo Stato: articolo 827), l’atto di rinuncia al diritto di comproprietà è menzionato principalmente:
- nell’articolo 882, che consente al comproprietario del muro comune di liberarsi dalle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al suo diritto di comunione del muro;
- nell’articolo 1104, che consente al comproprietario di una cosa comune di liberarsi dalle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune nonché dalle spese deliberate dalla maggioranza dei comunisti, rinunziando alla sua quota di comproprietà della cosa comune.
In entrambi i casi, l’effetto della rinuncia è l’espansione proporzionale delle quote di comproprietà di titolarità degli altri comproprietari: ad esempio, se la proprietà di un edificio spetta a quattro persone, in quote eguali fra loro, la rinuncia di uno di essi provoca che gli altri tre divengono comproprietari in ragione di un terzo per ciascuno.
Ora, la vicenda interpretativa che, di fatto, ha bloccato la stipula di atti di rinuncia al diritto di proprietà immobiliare, ha frenato anche la stipula degli atti di rinuncia alla quota di comproprietà: infatti, nonostante che la legge preveda espressamente questa rinuncia, vi era pur sempre il pericolo che vi fosse una pretesa di risarcimento del danno dimostrato dai comproprietari che subissero l’espansione delle loro quote di comproprietà a causa dell’altrui rinuncia. Infatti, uno dei più rilevanti argomenti che il Demanio aveva sollevato per opporsi alla stipula di atti che provocassero l’acquisto dell’immobile rinunciato da parte dello Stato era appunto che la rinuncia unilaterale può provocare costi imprevisti per lo Stato (manutenzione, demolizione, messa in sicurezza, bonifica eccetera).
Dopo la sentenza 23093/2025 appare, dunque, scongiurato il pericolo che il comproprietario rinunciante possa essere convenuto in responsabilità da parte dei comproprietari accresciuti. In primo luogo, in quanto egli sta esercitando un suo diritto: per definizione, l’esercizio di un diritto (può bensì provocare fastidio al prossimo, ma certo) non provoca un danno “ingiusto” (articolo 2043 del Codice civile) e, come tale, non provoca un danno risarcibile. In secondo luogo, perché il comproprietario accresciuto, se la situazione non gli aggrada, può anch’egli, a sua volta, rinunciare al suo diritto di comproprietà; e, se da una situazione di tanti comproprietari, ne rimanga alla fine uno solo, quest’ultimo può anch’egli, del tutto legittimamente, rinunciare al diritto di cui, a suon di rinunce, è divenuto esclusivo titolare, provocandone l’acquisizione da parte dello Stato.
Fonte: Il Sole 24 Ore