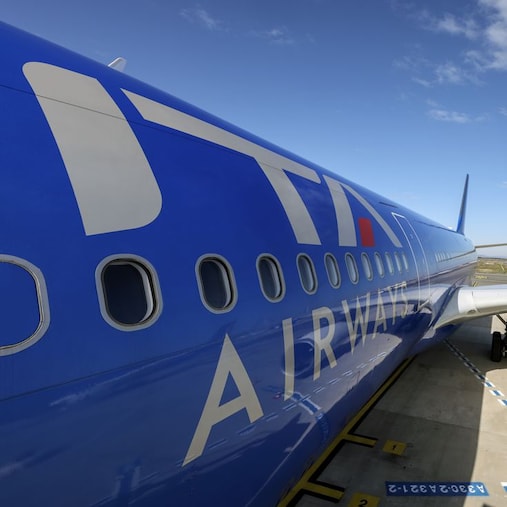Le donne che fecero l’archeologia e la fotografia
Lo sguardo e la coscienza, i particolari e l’eleganza. La fotografia, datata 1914, che Esther B. Van Deman scatta al Piccolo teatro di Pompei per immortalare l’opus reticulatum rappresenta al meglio la mostra fotografica Women and Ruins: Archaeology, Photography, and Landscape, in corso all’American Academy di Roma. Quella immagine, una stampa d’epoca, conservata nella stessa Accademia, testimonia il coraggio e l’acume di alcune donne che, a inizio Novecento, arrivano in Italia, restano folgorate dalle rovine e si fanno croniste e studiose. Capiscono di essere nel posto giusto al momento giusto per scrivere la storia. Van Deman ritrae la tecnica costruttiva con una foto perfetta, geometrica, quasi un quadro astratto e dimostra la sua coscienza di archeologa facendo scendere con elegante morbidezza – solo una donna poteva scegliere così – un metro per capire le dimensioni dell’opera: lo sguardo, il particolare si fanno scienza.
Accanto a Esther Van Deman, la mostra ricostruisce con passione i viaggi e le ricerche di Marion Elizabeth Blake (1892-1961), le sorelle Agnes (1856-1940) e Dora (1864-1948) Bulwer, Gertrude Bell (1868-1926), Maria Pasolini Ponti (1856-1938). Sono americane, britanniche e italiane, sono tre borsiste all’Accademia a Roma, la famosa esploratrice Bell e la storica Pasolini Ponti, soprattutto «sono donne moderne che attraversano l’Italia, che sanno vincere i pregiudizi in nome dell’archeologia e si rendono conto di essere testimoni di una radicale trasformazione dell’Italia», spiega Lexi Eberspacher, una delle curatrici e Programs Associate for the Arts all’Accademia. Roma diventa capitale nel 1871, la città è un cantiere e gli occhi delle studiose viaggiatrici sono oggi i nostri occhi. Arrivano a Roma attratte dall’antico e dal clima internazionale della città, che, nella seconda metà dell’Ottocento, vede nascere molte istituzioni internazionali. Così, le protagoniste della mostra, ad esclusione di Gertrud Bell che si ferma solo nel 1910 a Roma, trascorrono lunghi periodi in città e fermano il ripensamento in atto con le loro macchine fotografiche. Dora e Agnes Bulwer, che frequentano il direttore della Scuola Britannica, Thomas Ashby, e l’archeologo Rodolfo Lanciani, scelgono i Plutei Traiani del Foro Romano o i resti della Tomba dei Claudii in Piazza Venezia, Esther Van Deman la statua di una Vestale nell’Atrium Vestae o un tratto delle Mura Serviane. Sono – ed è anche uno dei capitoli della mostra – “rovine parlanti”, come già le aveva definite Piranesi: parlano di un passato luminoso che va documentato prima che scompaia. E allora Gertrude Bell mostra il suo interesse ritraendo capitelli e colonne in primo piano quasi fossero volti che cercano il dialogo dopo duemila anni. Marion Blake, che viaggia con Van Deman e registra le visite ai siti anche nei loro libri di appunti, è nell’antica città di Peltuinum, lungo la Via Claudia Nova, a nord di Roma, e documenta la costruzione in opus reticulatum delle gradinate del teatro o il Monte Velino da Alba Fucens (Massa d’Albe) quasi fosse una rovina-monumento.
Le donne immortalano e si fanno immortalare, anche questa è coscienza del loro ruolo: «In molte foto – argomenta Caroline Goodson, curatrice e Andrew W. Mellon Humanities Professor – appaiono figure femminili solitarie immerse tra le rovine, sono fuse con il paesaggio e paiono dire alla storia che loro sono paesaggio della storia». È una mostra di grandi consapevolezze, anche quella di avere rispetto degli uomini e delle donne che vengono ritratti fra colonne e templi: le archeologhe appartenevano a un’élite sociale e intellettuale che poco aveva da spartire con la povera gente, i contadini. Eppure, questi occhi femminili hanno un approccio umano: le sorelle Bulwer fotografano le capanne di paglia, vicino a Gabii, e la macchina fotografica è un modo discreto per entrare in questi mondi.
Ancora grandi spazi ed edifici nella sezione “La forma di un muro”: Esther Van Deman studia le tecniche costruttive, pensando forse a un manuale. Ci sono una parete del Tempio della Fortuna di Palestrina e le Mura Aureliane: l’archeologia entra nei nostri occhi per farsi contemporanea ed eternare il coraggio di queste donne che si davano forza l’un l’altra. Le fotocamere evolvono – quelle in mostra sono due gioielli –, e aumentano le possibilità tecnologiche ma a fare la differenza è il cuore delle donne e il loro sapersi meravigliare perché, come scrive Gertrud Bell a Van Deman «questo è un sogno di bellezza».
Women and Ruins: Archaeology, Photography, and Landscape
Fonte: Il Sole 24 Ore