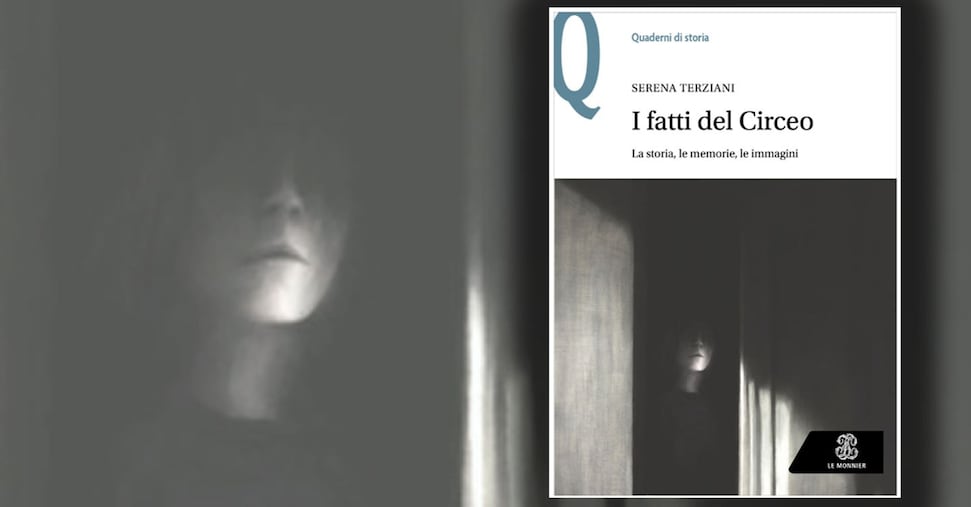
Le vittime del Circeo e l’infamia di quel processo
Si soffre, leggendo questo saggio di Serena Terziani, dottoressa di ricerca alla Sapienza di Roma che ha affrontato con coraggio la sfida di una ricostruzione meticolosa e basata sulle carte dell’orrore del Circeo. Si soffre non solo perché si precipita nell’abisso di quella violenza, costata cinquant’anni fa la morte a Maria Rosaria Lopez e una vita da sopravvissuta segnata per sempre a Donatella Colasanti (morta nel 2006). Non solo perché ci presenta i tre aguzzini, ragazzi della Roma borghese, in tutta la loro glaciale crudeltà e senza mai un segno di pentimento.
Si soffre per il dopo. Per un processo che ci dà la misura dell’impreparazione e dell’inadeguatezza della giustizia di fronte alla violenza sessuale (e del resto nel 1975 eravamo, incredibilmente, lontani dal reato contro la persona: sarebbero dovuti passare altri 21 anni per avere una legge che si lasciasse alle spalle il “buon costume” e la “moralità pubblica”). Si è detto tante volte dell’abominio di interrogatori che colpevolizzano le aggredite, di avvocati e giudici senza un briciolo di sensibilità e capacità di capire la vittima, ancora prima di empatizzarvi. La lettura, però, è un’altra cosa. Ci si sofferma, si interiorizza, ci si immedesima. Ci si chiede come sia stato possibile che Donatella Colasanti, ridotta in fin di vita nel bagagliaio di un’auto accanto al cadavere della sua amica dopo due giorni di sevizie raccapriccianti, sia stata sottoposta a un secondo calvario. Fatto di domande insinuanti se non accusatorie e screditanti, di proposte irricevibili (il tentativo delle famiglie dei colpevoli di “comprarla” con un risarcimento di 24 milioni di lire), di ore di sopralluogo nella villa maledetta a spiegare quello che aveva vissuto, il come, il quando… E dopo l’ergastolo comminato in primo grado a Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira, trascorso un anno, il dover rivivere tutto da zero per il processo di Appello, con l’amarezza per la riduzione della pena stabilita per Guido.
Lo scopo di questo saggio – nel mettere nero su bianco, scientificamente, I fatti del Circeo (come dice il titolo) – è di mostrare anche come quello sia stato un caso spartiacque per il dibattito pubblico che generò, per la rivolta delle donne in piazza e nelle aule del processo, per una nuova consapevolezza che si faceva lentamente strada nella nostra società. Terziani esplora quanto nel tempo si è susseguito, l’attenzione rivolta dal cinema e dalla letteratura perché non si affievolisse la memoria. La riflessione sul linguaggio si è intensificata, si sono moltiplicati i convegni, e dopo l’approvazione della legge nel ’96 – grazie al fronte comune delle parlamentari di diverso colore politico – si è andati avanti.
Le cronache ci dicono che tutto questo non è bastato; spesso affiorano, anzi, inquietanti arretramenti. Più che mai, dunque, questo libro è necessario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Fonte: Il Sole 24 Ore



