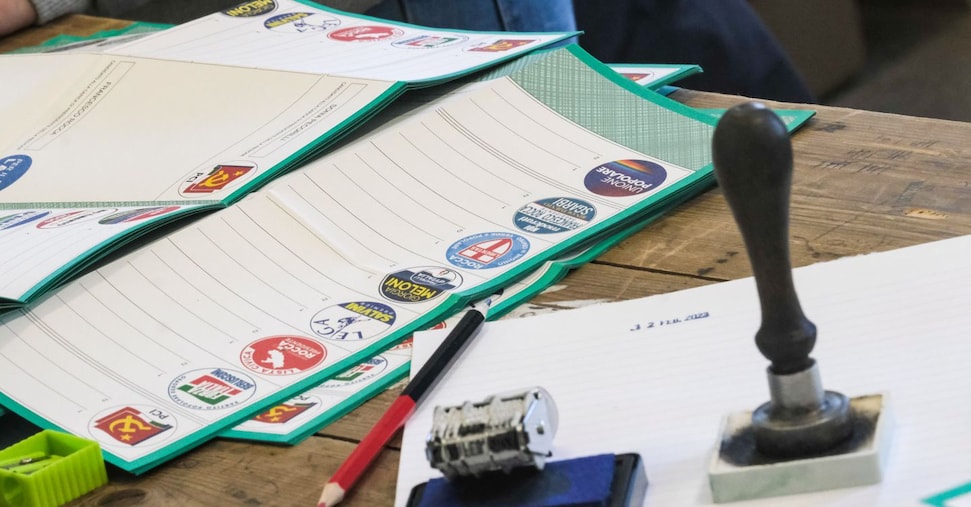Lubec 2025: cantiere per valutare l’impatto culturale
L’impatto della cultura sull’ambiente e sulla società è un tema molto dibattuto negli ultimi anni, soprattutto da quando ci si è resi conto che un museo, un festival o una mostra d’arte possono incidere sui processi democratici e partecipativi dei cittadini, oltre che avere un ruolo importante nel dare impulso all’attivazione di processi economici virtuosi e alla creazione di sistemi inclusivi: si pensi al welfare e alla partecipazione democratica. L’interesse è legato non solo all’urgenza di giustificare gli investimenti pubblici, sempre più esigui a causa della cronica riduzione delle risorse, ma anche al desiderio, sempre più diffuso, di comprendere come l’individuo, un’organizzazione e una comunità possano essere trasformati da un progetto culturale e come questo cambiamento possa tradursi in un numero o in un indice.
La valutazione della cultura
L’edizione 2025 di LuBeC, Lucca beni culturali, è stata l’occasione per riflettere sul tema importante della valutazione multidimensionale degli impatti dei progetti culturali nell’ambito dello sviluppo sostenibile; nel corso del convegno “Valutare l’impatto dei progetti culturali: framework di riferimento, metodologie e strumenti” sono emersi diversi spunti riguardo alla visione sempre più comune che la cultura non può essere solo valutata dal numero di ingressi, fatturato da biglietteria, bookshop, bar e ristorante, ma esistono altre strade.
Un nuovo metodo a Brescia
Stefano Karadjov, direttore della Fondazione Brescia Musei, ha presentato una nuova metodologia di analisi dell’impatto di tipo qualitativo, sviluppata in collaborazione con il consorzio AASTER, che vede il museo come un’autonomia funzionale della cultura. Sono state fatte delle interviste e dei focus group a circa settanta stakeholder del territorio, quali rappresentanti di enti locali, politici, direttori e presidenti di istituzioni museali, ai rappresentanti delle principali aziende e agli organi di Confindustria, Camere di Commercio e rappresentanti delle università, ecc. Le interviste sono state raggruppate in tre cluster, mondo dell’impresa, associazionismo e istituzioni e, per ciascuno, sono stati individuati i driver su cui si sono articolate le domande. Nel primo cluster, ad esempio, i temi riguardano: i fattori che rafforzano la propensione delle imprese a investire nel sistema culturale e nel patrimonio, il ritorno per l’impresa e l’impatto del turismo. Nel secondo cluster sono stati analizzati la capacità di fare rete, lo stato di salute del territorio, la capacità di inclusione e di affrontare i problemi delle fasce più deboli, mentre nell’ultima categoria dedicata alle istituzioni i driver si riferivano alle criticità legate all’impatto dell’over-tourism sui musei, i cambiamenti dei pubblici e della governance, la sostenibilità finanziaria. Le interviste confluiranno in un rapporto che sarà presentato il prossimo 25 ottobre, in occasione di Ravello Lab, dal quale emerge un quadro molto preciso di istruzioni che i musei potrebbero seguire in funzione del rinnovato ruolo che stanno assumendo: un luogo che diventa dialogo tra diversi mondi, che fa turismo e che aggrega le comunità, attivando processi di partecipazione e co-progettazione. La Fondazione sta spostando i suoi metodi di valutazione dalla raccolta e aggregazione di dati alla forma di interviste mirate, i cui risultati saranno raccolti in quaderni digitali, sintetici e di agevole lettura.
L’esperienza della Capitale della Cultura di Parma
Francesca Velani di Promo PA, organizzatrice dell’evento, in collaborazione con Roberta Ghilardi di Deloitte, Isabella Mozzoni dell’Università degli Studi di Parma hanno presentato Calibro, una piattaforma per la valutazione degli impatti generati dalle progettualità culturali in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile. La piattaforma, finanziata con fondi PNRR, Toc Transizione digitale, è pensata per supportare le organizzazioni culturali pubbliche e private nella valutazione di progetti e programmi culturali e nasce dell’esperienza sulla misurazione degli impatti di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21. In quella esperienza sono state analizzate attività culturali eterogenee e valutati progetti di diversa natura, sia tipologica, sia per ambito: dalle arti visive a quelle performative, per arrivare al video-gaming e al mondo dell’audiovisivo. La piattaforma si basa su principali framework internazionali esistenti in materia, su tutti l’UNESCO Culture 2030 Indicators che considera la cultura sia come settore di attività a sé stante, sia quale elemento trasversale ai Sustainable Development Goals definiti dall’ONU nell’Agenda2030, dove la cultura, stranamente, non compare. Inoltre la metodologia ha preso ispirazione anche dai principali standard di reporting per la sostenibilità, con particolare riferimento ai GRI Standards e agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Il risultato è la valutazione del progetto basato su quattro aree tematiche, quali ambiente e resilienza, benessere economico e prosperità, conoscenza e competenze, inclusione e partecipazione. In base al livello di maturità dell’organizzazione che valuta il progetto si possono scegliere tre livelli analisi, base, intermedio, avanzato, i quali contengono un numero crescente di domande, indicatori e data point. La valutazione si fonda su una scala Likert a cinque punti, dove gli indicatori sono costruiti in modo tale da rendere oggettiva l’assegnazione dei punteggi da 1 a 5, con 0 assegnabile soltanto alla completa assenza del dato. Il punteggio assegnato tramite Calibro non rappresenta un giudizio di merito sulla proposta culturale, ma l’obiettivo è dunque mettere in evidenza l’impatto generato e supportare un percorso di miglioramento continuo. La piattaforma resterà in fase di test e sperimentazione fino a dicembre e sarà online da febbraio 2026, a disposizione di musei, enti, istituzioni e imprese.
Fonte: Il Sole 24 Ore