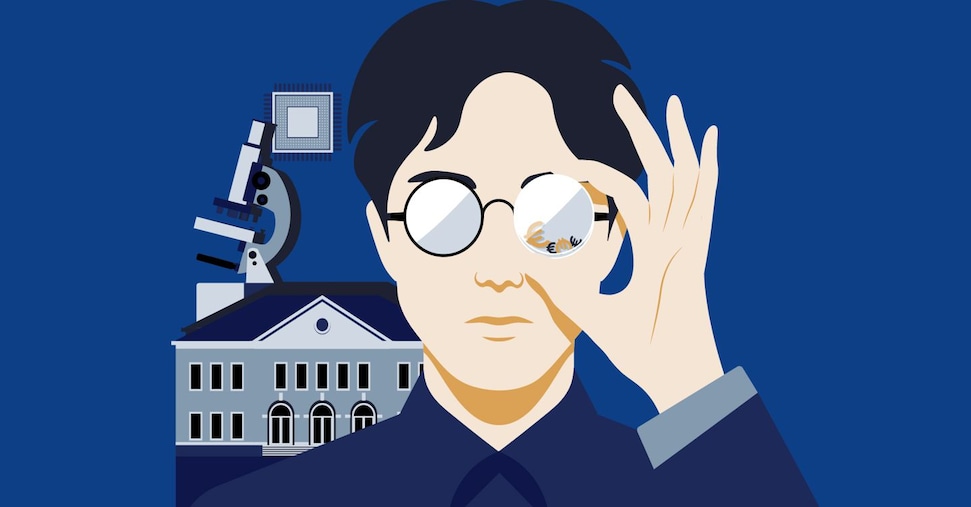Milano, il futuro del Leoncavallo merita un confronto pubblico
Incalza da giorni il dibattito pubblico attorno alla chiusura del Leoncavallo, lo storico centro sociale milanese nato nel 1975 nell’omonima via e sgomberato il 23 agosti scorso. Lo sgombero, annunciato e rinviato più volte dal 2003, è tornato al centro dell’agenda politica dopo che lo scorso novembre il Ministero dell’Interno ha riconosciuto un risarcimento di 3 milioni di euro alla famiglia Cabassi, proprietaria dell’immobile, chiudendo così un contenzioso che in origine aveva stimato perdite superiori ai 10 milioni. La vicenda, tuttavia, non può essere ridotta a un semplice tema di ordine pubblico poiché significherebbe trascurare la portata storica di un luogo che è stato per decenni uno dei principali centri di produzioni culturali indipendenti italiani nonché simbolo di partecipazione civica ed inclusione. La sua parabola diventa, invece, la cartina tornasole non solo di una Milano che nel perseguire un determinato modello di crescita sacrifica progressivamente questi spazi di aggregazione alternativi, ma anche di un Paese che fa ancora fatica a riconoscere e valorizzare le produzioni culturali più underground.
Dalla controcultura all’istituzionalità
In quasi cinquant’anni di attività il Leoncavallo ha rappresentato non solo un presidio di comunità, ma anche un centro culturale con un impatto non marginale sul quartiere, storicamente popolare. I suoi spazi si sono trasformati in una tela urbana che nel tempo ha accolto le opere di street artist di rilievo internazionale, da Blu a Ozmo, da Atomo a Pao, fino a Mr. Wany, Zed1, Tv Boy, Bros, Tawa, Zibe, Dario Arcidiacono, Frode, Anna Muzi e Giacomo Spazio. Un patrimonio che nel 2006 spinse Vittorio Sgarbi, allora assessore alla Cultura del Comune di Milano, a definirlo “la Cappella Sistina contemporanea”, auspicando la sua trasformazione in museo.
Anche la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, nel 2023, ha riconosciuto il valore storico e artistico dei graffiti custoditi nei sotterranei del Leoncavallo, sottoponendoli a vincolo di legge ai sensi dell’art. 50 del Codice dei Beni Culturali, in base al quale “è vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti … ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista” (così co. 1 della norma). Un riconoscimento storico, il primo a livello ministeriale sul fronte della Street art, che sancì la genuinità e l’unicità di quell’esperienza pionieristica istituzionalizzandone il valore storico e culturale.
Per comprendere l’importanza di quel riconoscimento bisogna tornare al 2003 quando, nei sotterranei del Leoncavallo, nello spazio ribattezzato Daun Taun si svolse il nono e ultimo HIU – Happening Internazionale Underground, ideato dall’artista Marco Teatro e rapidamente divenuto un punto di riferimento per l’arte underground italiana. Per tre giorni decine di artisti italiani e internazionali, dai pionieri del writing come Vandalo, Atomo, Shah, Giacomo Spazio e Paolo Buggiani, ai giovani emergenti come Bo130, Microbo, Ozmo, Pao, 108, Abbominevole, Santy, Pus, Sea Creative, invasero ogni superficie dei sotterranei dando vita a una grande jam collettiva. Quella che doveva essere un’esperienza effimera rimase invece congelata nel tempo: poco dopo il Daun Taun venne chiuso per motivi di sicurezza e nessuno vi fece più ingresso fino alla riscoperta quasi vent’anni dopo nel periodo post-pandemico. Da lì prese avvio un percorso di valorizzazione che, sotto il coordinamento della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, coinvolse INWARD – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, fino a giungere alla definitiva consacrazione istituzionale.
Quando la Street art diventa patrimonio tutelato
Negli ultimi anni la Street art ha conosciuto una vera e propria inversione critica. Ciò che un tempo veniva liquidato come vandalismo oggi è riconosciuto come espressione artistica, valorizzata nei musei e sul mercato dove raggiunge quotazioni sempre più alte. Come agli albori, la sua forza risiede ancora nell’indipendenza dai circuiti istituzionali e tentare di controllarla significherebbe snaturarla.
Negli ultimi anni, anche il diritto ha iniziato ad occuparsene: le opere degli street artist infatti, pur potendo integrare ipotesi penalmente rilevanti, se originali e creative sono sempre tutelate dalla legge sul diritto d’autore (legge 633/1941), che riconosce ai rispettivi autori sia i diritti patrimoniali sia quelli morali previsti, indipendentemente dalla liceità dell’intervento o dall’assenza di registrazioni formali. In alcuni casi, come per le produzioni del Leoncavallo, tali opere potrebbero persino essere ricondotte alla categoria dei beni culturali ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), con la conseguente necessità di un’autorizzazione della Soprintendenza per qualunque intervento di rimozione o copertura. Non mancano inoltre esempi in cui la Street art ha inciso direttamente sul valore di mercato degli immobili su cui sono state realizzate le opere. Emblematico è il caso del palazzo veneziano in Campo San Pantalon, dove nel 2019 è comparso il murale “Naufrago bambino” di Banksy: l’opera, realizzata in occasione della Biennale, ha fatto lievitare il valore dell’edificio fino a 4,5 milioni di euro, quadruplicando il prezzo di partenza. Resta ora da capire se dinamiche analoghe potranno riguardare anche l’immobile di via Watteau, oggi iscritto a bilancio per 2,64 milioni. I primi segnali, intanto, sono già arrivati dal mercato: a Piazza Affari i titoli Brioschi, azionista di maggioranza de L’Orologio (la società della famiglia Cabassi), hanno segnato un +12,42% al 25 agosto per poi scendere, mentre Bastogi, azionista di maggioranza di Brioschi, ha messo a segno un rialzo del 10,6% (al 28 agosto 2025).
Fonte: Il Sole 24 Ore