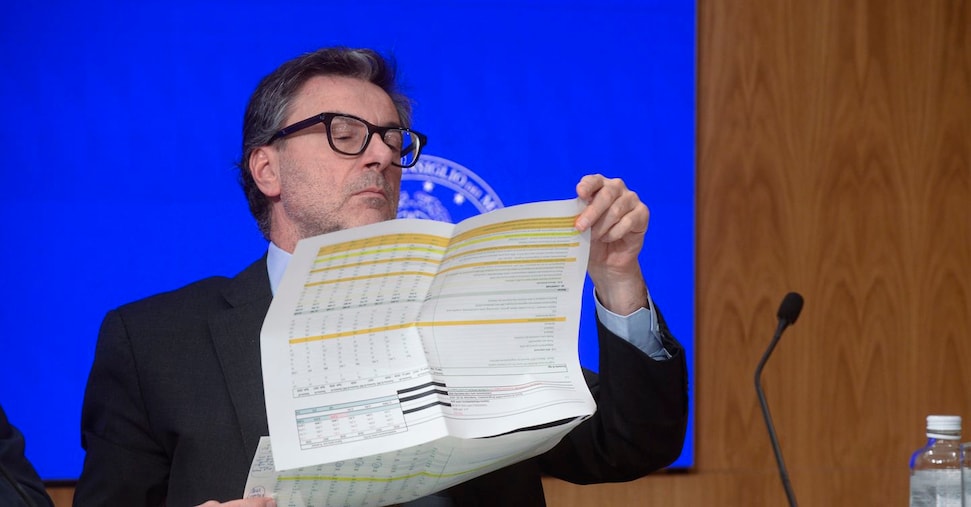Perché non possiamo non dirci bembiani
Chi – nato entro il finire degli anni Settanta (per i più giovani non saprei dire) – non ricorda l’ampio corredo di obblighi e di divieti della lingua italiana, imposti dalla maestra delle Elementari come dei punti fermi assoluti e indiscutibili? Quelli sui quali vertevano anche le correzioni e le con seguenti valutazioni di “pensierini” e temi: dalla fobia per l’uso di lui, lei e loro in funzione di soggetto (da sostituire con gli eterei egli, ella o essa, essi ed esse) all’invito a rovistare fra i (cosiddetti) sinonimi alla ricerca delle lezioni meno banali – volto e non faccia, eseguire e non fare – in una inquietante e ansiogena caccia alle ripetizioni: pare addirittura che gli studenti italiani abbiano più confidenza col dizionario dei sinonimi (e contrari) che con quello generale della lingua. Si tratta di una pedagogia che ci riguarda tutti, dalle Alpi all’Etna, e che è stata tra i fattori più potenti della nostra coesione nazionale. Ebbene, essa dipende da un signore, Pietro Bembo, e dal suo trattato, di cui quest’anno si celebra il cinquecentesimo anniversario della pubblicazione: le Prose nelle quali si ragiona della volgar lingua. Ossia il testo che segna l’atto di nascita della lingua italiana, chiudendo la questione aperta da due secoli circa la possibilità di un affrancamento definitivo dall’uso del latino e della conseguente individuazione di un italiano letterario tra le decine e decine di dialetti che si parlavano lungo tutta la Penisola.
Se c’era qualcuno che avesse coscienza della quasi incomunicabilità tra le varie regioni d’Italia era proprio Bembo: figlio del diplomatico ed erudito Bernardo, e veneziano di nascita, aveva vissuto la giovinezza a Firenze e a Roma, per salire a Bergamo e ridiscendere, a perfezionare il greco, fino a Messina (con sosta a Napoli). Successivamente aveva abitato a Padova, Ferrara e Urbino, nuovamente a Venezia e infine a Roma, dove venne creato cardinale (e giace sotto il pavimento della Minerva). Nelle sue Prose l’avrebbe messo nero su bianco: «maravigliosa cosa è a sentire quanta variatione è hoggi nella volgar lingua pur solamente, con la qual noi et gli altri Italiani parliamo, et quanto è malagevole lo eleggere et trarne quello essempio, col quale più tosto formar si debbano et fuori mandarne le scritture.»
Se Dante aveva aperto la zuffa, lasciando (men che) a mezzo il suo De vulgari eloquentia, e se nel corso del Quattrocento non erano mancati dotti e letterati a ribadire che l’italiano letterario aveva pari dignità del latino ed era in grado di tenere il passo delle lingue europee, fu tuttavia nel Cinquecento che la questione divenne impellente e suscitò proposte dai quattro angoli della Penisola. Tutte contrastanti tra loro, neanche a dirlo. Tolto, infatti, lo zoccolo duro dei nostalgici (in questo caso, del latino), che in Italia prospera dai tempi almeno di Orazio Flacco e interviene ad ogni eventualità di schieramento (politico, giuridico, estetico, civile, sportivo, religioso-liturgico e gastronomico), da un lato, c’erano quelli che, come il mantovano Baldassarre Castiglione, sostenevano che fossero le varie corti signorili d’Italia il luogo dell’elaborazione della lingua comune, che sarebbe dunque stata pluralista e variegata, specchio della conversazione brillante e cortese che si praticava a Urbino, ma anche a Milano, a Mantova, a Napoli, a Roma e a Firenze. Una lingua mossa, poco codificata, naturale e aristocratica insieme. Cortigiana e fluida. Dall’altro lato, stava il partito del vicentino Gian Giorgio Trissino, favorevole a elaborare una lingua comune a partire dai risultati migliori e dalle proposte più interessanti di quelle locali: una sorta di fecondazione in vitro, iperdotta e volontarista, solo apparentemente democratica e aperta, ma soprattutto di scarsissima attuabilità pratica. Da Belluno Pierio Valeriano era il capofila di coloro che si opponevano al prestigio e al peso che, tra tutti i dialetti d’Italia, il fiorentino sentiva di avere ed andava conquistando in ambiti sempre più vasti dell’opinione pubblica, arrivando a sbeffeggiare la gorgia toscana come dagli spalti di un “Napoli-Fiorentina” di Serie A. Dall’altra curva, Niccolò Machiavelli, forse, e sicuramente Giovan Battista Gelli guidavano la tifoseria viola, che reputava quella della propria città, anzi quella dei propri vicoli, la vera e unica lingua italiana, quella che in tutto il resto della penisola ci si sforzava di parlare e di imitare, ma che lì germinava spontanea come acqua da fonte. Una lingua popolare, che dai rioni sale agli scrittoi e alle grandi biblioteche, per fluire nella penna degli uomini di lettere. La cui grammatica e le cui regole sarebbero state indotte dall’uso comune, come una linfa popolare e vivace, e non dedotte dall’alto, come siamo abituati a fare sin dalle scuole elementari. Il lettore a questo punto avrà riconosciuto l’annosa “questione della lingua” che ogni italiano ha affrontato a scuola, dall’Etna alle Alpi, sempre con quell’identico velo di perplessità non tanto quanto all’oggetto della discussione, che fluttua nell’empireo dell’erudizione, quanto al senso e alla necessità stessi di tanto contendere. Eccola, invece, brillare d’improvvisa smagliante necessità.
Cinquecento anni fa, come si diceva, l’intervento di Bembo, che ribaltava la questione in maniera perentoria e definitiva, partendo da un assioma che non lasciava (molto) scampo: «non si può dire che sia veramente lingua alcuna favella che non ha scrittore». Una lingua letteraria, cioè, per essere tale, deve poter vantare una tradizione illustre e accreditata, dei modelli autorevoli: e dunque fuori tutti, ad eccezione del fiorentino, che a differenza delle poche altre blasonate scuole letterarie – la siciliana in primis – poteva far valere almeno due o tre autori di razza: Dante, Petrarca e Boccaccio, dai quali trarre, con andamento aristocratico dall’alto verso il basso, le regole del futuro italiano letterario. Quelle nelle quali Manzoni ha poi candeggiato il suo romanzo e che ci sono state inculcate con serena perentorietà sin dalle scuole Elementari. Qualcuno direbbe che tutti, come italiani, non possiamo non dirci bembiani, ed è per questo che la Biblioteca Apostolica Vaticana offre la possibilità, almeno per un giorno, di assistere a un convegno su Bembo come sommo legiferatore della lingua e di ammirare i suoi manoscritti e le edizioni a stampa delle Prose, originali e contraffatte, il 23 ottobre prossimo.
Fonte: Il Sole 24 Ore