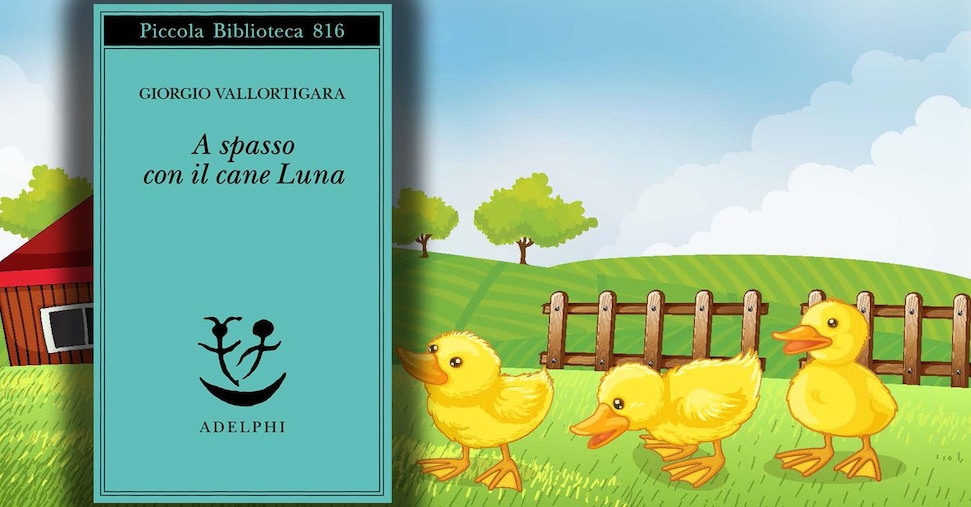
Pulcini e nuvole: anche loro giocano a indovinare le forme?
E se anche i pulcini vedessero le facce nelle nuvole? Grandi facce coscienza? Se lo chiede Giorgio Vallortigara, professore di Neuroscienze e cognizione animale all’Università di Trento in A spasso con il cane Luna (Adelphi, pagg. 222, € 14), un libriccino pieno di sorprese. Vallortigara è una vecchia conoscenza di questo giornale: la prima volta che il suo nome vi è comparso, nel 2005, s’era fatto notare per aver scritto un saggio sul cervello di gallina, sostenendo che era assai utile per capire quello umano. Già. E ne mostrava molte prodezze, come la capacità di fare una stima della numerosità dei chicchi.
La seconda volta invece, nel 2007, ne scrivemmo perché aveva pubblicato uno studio su un pesce filosofo. Un piccolo variopinto pinnipede del lago Tanganica, l’Astatotilapia burtoni che – alla stregua di Aristotele (ricordate il classico sillogismo: «Tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, dunque Socrate è mortale»?) – sa fare l’inferenza transitiva: dedurre cioè una relazione sconosciuta sulla base della conoscenza di un’altra relazione. In pratica riesce a fare questo tipo di riflessione: se Marcello è più alto di Claudio, e Claudio è più alto di Luca, allora Marcello è più alto di Luca. Non che al pesciolino importi molto chi sia lo spilungone del gruppo: gli interessa piuttosto capire chi – tra i suoi simili – picchia più forte, così da risparmiarsi qualche inutile zuffa.
Dopo quella seconda volta, Vallortigara ha iniziato a scrivere direttamente sulla «Domenica», e alcuni degli articoli pubblicati sono raccolti in questo volumetto che – tra la mente di un bassotto e il cervello di un matematico, tra un prodigioso blob unicellulare e un pappagallo cinerino altruista – saltella con una leggerezza da canarino – a volte con qualche balzo da cavalletta – tra alcune delle domande più affascinanti che il sapiens si pone da millenni: che cosa è l’intelligenza? che cosa è la coscienza? chi la possiede? la matematica è una lingua? pensiamo attraverso il linguaggio? perché qualcuno è altruista? dove è custodita la memoria?
Leggendolo, scopriamo ad esempio che quello di cercare le forme nelle nuvole è proprio un pallino di Vallortigara e ha qualcosa a che vedere coi lupi, coi cani, col nostro bisogno di raccontare storie. Come? Si parte da Alcibiade, un bassotto che col suo padrone «ha intessuto una trama di affetti e comprensione reciproca straordinariamente fitta». Non aspettatevi possa accadere con un lupacchiotto: 15mila anni fa è iniziato il processo di domesticazione che ha cambiato oltre che la morfologia, anche la mente del lupo grigio rendendolo molto più capace di “leggere” i segnali comunicativi di un’altra specie, la nostra. La domesticazione, scrive Vallortigara, è una sindrome che pare aver premiato chi aveva un ritardo o un difetto ereditabile nello sviluppo delle cellule staminali della cresta neurale che ha provocato negli ex-lupi tanti cambiamenti: muso accorciato, orecchie flosce, abbaio festoso, scodinzolio, tratti neotenici (ovvero più simili a quelle dei cuccioli), ma anche uno sviluppo più lento o immaturo delle ghiandole surrenali – ghiandole che rilasciano gli ormoni dello stress e servono a preparare l’animale alla lotta e alla fuga – facendo dei cani dei docili simpaticoni. Del resto, anche in animali molto diversi quali i pesci zebra, uno sviluppo alterato della cresta neurale – in questo caso indotto artificialmente, rendendoli transgenici – ha un effetto “pacificante”: i pescetti dal Dna modificato sono risultati molto meno ansiosi.
Il primatologo di Harvard, Richard Wrangham, sostiene che un meccanismo di domesticazione simile a quello che ha esercitato sul cane, l’essere umano l’avrebbe rivolto anche a sé stesso, rendendoci meno aggressivi dei cugini scimpanzé e aprendo la strada a menti capaci di sostenere forme di socialità basate più sulla cooperazione che sulla competizione. È così, probabilmente, che siamo diventati tanto bravi a leggere le menti altri, e a attribuire stati mentali quali desideri, scopi e intenzioni a qualunque cosa ci capiti a tiro, dal dispotico Alcibiade fino a figure geometriche fatte muovere opportunamente sullo schermo: nella nostra testa diventano immediatamente protagonisti di una storia. «Ecco il triangolo cattivo che sta inseguendo il cerchio, che scappa, poverino, consapevole che sta per essere raggiunto, ma il triangolo…»: Paul Bloom ha mostrato che anche bambini di pochi mesi attribuiscono a queste figure caratteri di “bontà” e “cattiveria”.
Fonte: Il Sole 24 Ore




