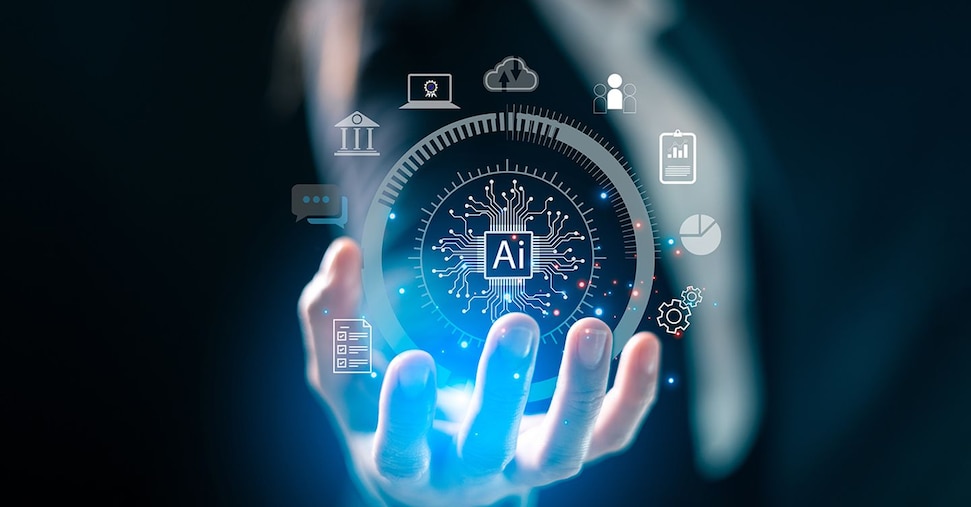Resilienza agricola e tecnologia per la sicurezza alimentare
La sicurezza alimentare è diventata uno dei parametri più sensibili dell’equilibrio mondiale. Oggi oltre 720 milioni di persone nel mondo non hanno accesso a cibo sufficiente, o sufficientemente sicuro: oltre a essere un indice di povertà non trascurabile, è anche la misura di una fragilità che si riflette su stabilità politica, mercati e salute pubblica. Ogni crisi — dal clima alla guerra, dalle pandemie agli shock economici — finisce per manifestarsi anche attraverso la fame. «Non vado a dormire pensando ai bambini che abbiamo salvato, vado a dormire con il cuore spezzato per quelli che non siamo riusciti a raggiungere, perché quando i fondi non bastano dobbiamo scegliere quali bambini mangeranno e quali no», ha spiegato il premio Nobel per la Pace 2020 David Beasley, già direttore del World Food Programme e intervenuto in Germania all’ottavo Laureate Meeting di Lindau dedicato alle scienze economiche. «E il paradosso è che, mentre ogni quattro o cinque secondi qualcuno muore di fame, viviamo nell’epoca con la maggiore ricchezza circolante della storia».
Effetti senza confini per la crisi alimentare
Il quadro delineato dalla Mappa delle 10 (+3) principali emergenze alimentari globali pubblicata la settimana scorsa da Azione Contro la Fame conferma una tendenza ormai strutturale: la crisi alimentare si concentra in pochi Paesi, ma con effetti che si propagano ben oltre i loro confini, alimentando instabilità e migrazioni. Oltre 196 milioni di persone in dieci Stati — Nigeria, Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Bangladesh, Etiopia, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Myanmar e Siria — vivono in condizioni di insicurezza alimentare acuta, mentre Haiti e Sud Sudan (oltre alla Striscia di Gaza, come ben noto) registrano livelli estremi. In ognuna di queste aree si intrecciano guerre, crisi climatiche, instabilità politica e ostacoli all’accesso umanitario. Quasi 30 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta, di cui 8,5 milioni in forma grave. «Durante il lockdown dell’ultima pandemia ho detto alle Nazioni Unite che avremmo rischiato di uccidere più persone per mancanza di cibo sicuro che per il virus», ha ricordato Beasley. «Chi vive di agricoltura non può permettersi di fermarsi: se blocchi i semi e i trasporti, non stai salvando vite, le stai condannando».
Cosa fare?
Ridurre la fame oggi significa agire su più piani assieme. Da un lato la resilienza dei sistemi agricoli: pratiche rigenerative, gestione del suolo, rotazioni colturali, micro‑irrigazione e pompe solari che riducono la dipendenza da combustibili fossili. Dall’altro la tecnologia, che consente di prevenire e gestire meglio le crisi. Un esempio? Grazie all’utilizzo di satelliti e sensori si possono raccogliere dati su precipitazioni e rese, poi si possono incrociare questi dati con i prezzi dei mercati locali per prevedere con settimane di anticipo le carestie. Quando il rischio supera una determinata soglia, si possono attivare finanziamenti anticipatori e trasferimenti digitali attraverso portafogli elettronici. In questo modo le comunità ricevono aiuti prima che la crisi esploda, con costi inferiori e maggiore efficacia. «La beneficenza è utile, ma non è la soluzione di lungo periodo», ha ribadito Beasley. «L’obiettivo non può essere distribuire aiuti a tempo indeterminato: dobbiamo mettere i Paesi nelle condizioni di bastare a se stessi». La Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che ricorre ogni 16 ottobre su iniziativa della FAO (la Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite), dedica quest’anno la sua attenzione a resilienza climatica e sostenibilità dei sistemi agroalimentari. In Italia la mobilitazione continua con campagne che uniscono sensibilizzazione e sostegno concreto, dalla scuola alle imprese. Il diritto al cibo, spiegano gli esperti, nasce dalla capacità di trasformare l’aiuto in autonomia e di coniugare scienza, governance e innovazione sociale. Le soluzioni esistono: produzioni locali, investimenti in infrastrutture agricole, micro-assicurazioni contro le perdite di raccolto e programmi di nutrizione scolastica che legano educazione, salute e reddito.
Il Nobel Beasley: «La politica vacilla, se il cibo è scarso»
Ma l’emergenza alimentare non riguarda solo la nutrizione: in uno scacchiere geopolitico complesso e in forte tensione, è un tema di sicurezza globale. «Un aumento del 5% o del 10% nei prezzi, in termini generali, può sembrare poco», ha osservato Beasley. «Ma in Paesi come la Repubblica Democratica del Congo o il Botswana può bastare a far crollare un governo: quando il cibo scarseggia, la politica vacilla». A questa instabilità si sommano gli effetti della disinformazione, che amplifica le paure e la sfiducia nelle istituzioni. La fame è una leva che muove le persone, soprattutto quando i figli non hanno abbastanza da mangiare. «Se non affrontiamo le cause a monte, paghiamo due volte», ha avvertito il premio Nobel. «Un milione di rifugiati siriani è costato alla sola Germania 125 miliardi di dollari in cinque anni: nutrirli in Siria sarebbe costato meno di cinquanta centesimi al giorno. E negli Stati Uniti vengono spesi 3.750 dollari a settimana per mantenere un bambino nei centri di accoglienza: con due dollari lo nutriremmo nel suo Paese».
Costruire sicurezza alimentare significa ridurre la vulnerabilità economica dei Paesi dipendenti dalle importazioni, diversificando fonti e rotte di approvvigionamento. In un mondo interconnesso, garantire il cibo equivale a rendere più solida la stabilità collettiva. «Il cibo è il linguaggio più universale che esista», ha detto Beasley, accorato sul palco davanti a 400 giovani economisti da tutto il mondo. «Può unire dove la politica divide, perché spezzare il pane insieme è un atto di fiducia. Se viene garantito il cibo, si riduce la paura, e di conseguenza la violenza».
Fonte: Il Sole 24 Ore