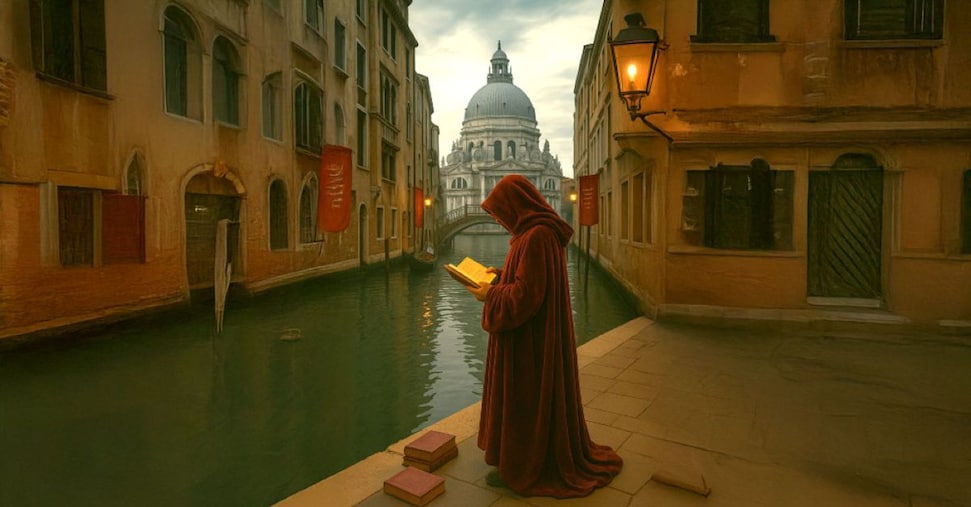Scrivere e tradurre: due braccia per nuotare
«Tradurre è riscoprire la scrittura» recita un verso di Nicola Gardini tratto da Tradurre è un bacio (Ladolfi, 2015), raccolta di poesie in cui l’autore indaga cosa significhi trasporre un’opera letteraria in un’altra lingua, riflessione che diviene il motore di moltissime altre, sulla poetica, sul linguaggio, sull’amore… le analogie e le metafore sbocciano a ripetizione. «La traduzione ha trasformato il mio rapporto con la scrittura» si legge in un altro elegante, sorprendente libro, questa volta sotto forma di una collezione di saggi di Jhumpa Lahiri: Perché l’italiano. Storia di una metamorfosi. Anche qui tradurre e ragionare sulla traduzione diventa un ottimo angolo visuale per cercare di capire cosa sia la letteratura, la poesia, l’autorialità. «Penso che scrivere e tradurre siano due aspetti della stessa attività, due facce della stessa medaglia, o forse due bracciate che, esercitando forze distinte ma complementari, mi consentono di nuotare coprendo distanze maggiori, e più abissali profondità, attraverso l’elemento misterioso della lingua» annota l’autrice.
Nata a Londra da genitori bengalesi e cresciuta negli Stati Uniti, si definisce «orfana» dal punto di vista linguistico e – dopo aver passato una vita a tradurre, in modo quasi inconsapevole, tra la cultura dei suoi genitori e quella del suo Paese – ha deciso di mettersi a scrivere in italiano, una lingua che amava senza averne possesso (e dunque era nella condizione di amare davvero). Un’esperienza che è stata un’occasione di libertà e di scoperta di una sé stessa potenziale. «”Perché l’italiano?” Per aprire le porte. Per vedere diversamente. Per innestarmi in altro. Tutto qui», risponde, usando la bellissima metafora dell’innesto: «una lingua, perfino una lingua straniera, è qualcosa di talmente intimo che entra comunque dentro di noi. Diventa una parte del nostro corpo, della nostra anima. Si radica nel cervello, esce dalla bocca. Col tempo si annida nel cuore. L’innesto che ho fatto mette in circolo un nuovo idioma, nuovi pensieri dentro di me». Metafora che ha anche una valenza politica: innesti sono pure gli immigrati che contribuiscono a dare vita a una nuova società. «Il concetto di innesto è un modo di capire un impulso umano, universale. Spiega il motivo per cui ognuno di noi cerca altro e di più, e spiega anche il meccanismo. Si può cambiare città, cittadinanza, corpo, viso, sesso, famiglia, religione. Attraverso l’innesto possiamo rifiutare le nostre origini, oggi più che mai. Benché un innesto sia un processo naturale il risultato può essere percepito come forzato, poco autentico. Chi lo subisce o chi lo opera (anche su se stesso) è visto con sospetto». Tuttavia, osserva Lahiri, per andare avanti, per sviluppare una civiltà, «è necessario cambiare la fonte di nutrimento».
Sorpresa dalle scrittrici e dagli scrittori italiani del secolo scorso che hanno dedicato molto tempo a praticare e promuovere l’arte del tradurre, «anche per sostenere un cruciale mandato estetico e politico, quello di aprire le frontiere linguistiche e culturali», Lahiri si inserisce nella loro scia. Lei che si definisce «un azzardato innesto geografico culturale», che fa della traduzione la sua principale chiave euristica, che cerca di scardinare l’idea che la traduzione e l’originale stiano in un rapporto gerarchico, dove la prima è derivativa e la seconda autentica, o – peggio – dove la prima è contaminata e la seconda è pura. Di qui il parallelismo – in un capitolo bello e ardito in cui analizza il mito di Eco e Narciso facendo dell’una il simbolo della traduzione, e dell’altro quello della scrittura – con chi auspica che l’America “torni ad essere grande” o sostiene che gli italiani vengono prima degli altri. Malati di narcisismo, finiranno per soccombere all’illusione che li inganna, come Narciso che «desidera, senza saperlo, se stesso; elogia, ma è lui l’elogiato, e mentre brama, si brama, e insieme accende e arde» (versi di Ovidio tradotti da Lahiri, che nella traduzione di Gardini in Chiedimi qualunque dono, Ponte alle Grazie, 2023 invece suonano così: «Desidera sé stesso e non capisce,/ gli elogi vanno a chi li fa, e bramando, /è bramato, e un incendio dà e riceve/ insieme»).
Il fatto che l’autrice abbia deciso, in un momento della sua vita, di scrivere libri in italiano (un «brancolare nella semioscurità», con una visione che da un lato è «compromessa», dall’altro diviene «fulminante»), e di avere poi, dopo una lunga riflessione, anche deciso di autotradursi per la versione inglese di alcuni di questi, diviene l’occasione per altre, originali osservazioni sull’identità autoriale, sul falso mito del testo definitivo (dalla versione inglese del testo italiano si è generata una terza versione italiana), sul possibile annientamento del testo che questa operazione produce, etc. Essere una scrittrice-traduttrice, osserva Lahiri, è dare valore sia all’essere che al divenire, perché «la letteratura non è normativa, bensì speculativa».
Tradurre è moltiplicare, anche le speculazioni (Non c’è parola per nessuna cosa/ Perché la cosa, quando esiste, è folla./ Un petalo non basta a far la rosa./ Tradurre è ricomporre la corolla»; Gardini, Giardinaggio, in Tradurre è un bacio). Già Lucrezio – qui nella splendida traduzione di Milo De Angelis (De rerum natura, Mondadori, 2022) – lo aveva evidenziato: «Una sola voce si divide all’improvviso in molte voci/ e giunge distintamente all’orecchio di ciascuno imprimendo/ la sua forma e il suo nitido suono alle parole».
Fonte: Il Sole 24 Ore