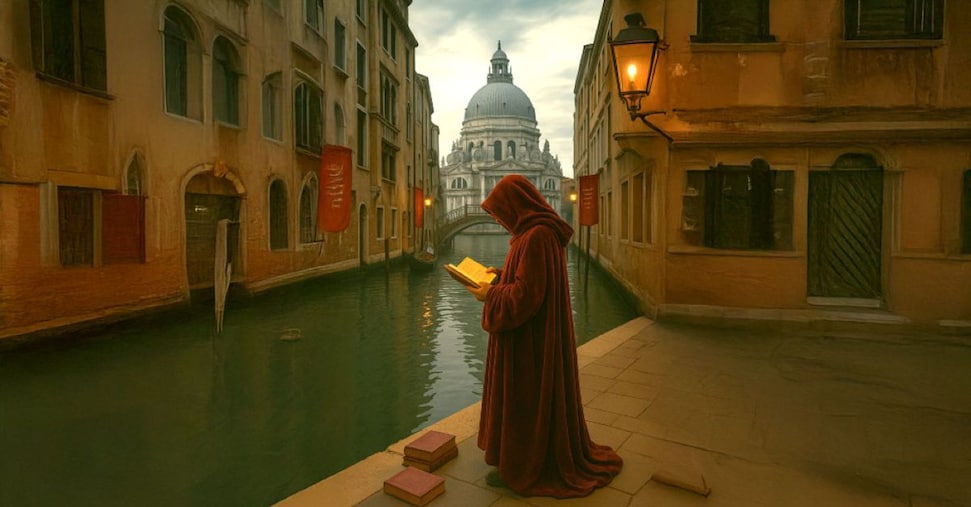Stocchi: non un atto di auto-celebrazione, ma di confronto
Francesco Stocchi, classe 1975 romano, è tra i dieci curatori la cui proposta è stata selezionata dalla Commissione di valutazione del MiC, composta dal direttore Generale Creatività Contemporanea e Commissario del Padiglione Italia Angelo Piero Cappello (con funzione di presidente), dal presidente del Comitato Tecnico-Scientifico per l’Arte e l’Architettura contemporanee Claudio Varagnoli e da tre personalità di alto profilo scientifico afferenti al settore dell’arte contemporanea: Ester Coen, Luca Aurelio Aldo Cerizza e Valerio Terraroli.
Dal 2023 Stocchi è direttore artistico del MAXXI di Roma, è stato attivo per molti anni ad Amsterdam come curatore del Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, curatore del programma espositivo della Fondazione Carriero di Milano, membro del Comité consultatif du Fonds de dotation de la Fondation La Fayette di Parigi e responsabile del programma artistico della Fondazione Memmo di Roma. Nel 2022 è stato curatore del Padiglione Svizzera alla 59. Biennale di Venezia e nel 2021 ha co-curato la 34. edizione della Biennale di San Paolo.
Ci racconti di te, del tuo percorso e della tua visione curatoriale? Soprattutto quali mostre che per impatto ed importanza possono essere qualificanti del tuo percorso?
Parlare di se lo trovo un esercizio complesso, forse perché mi sento forse piu un osservatore che un attore, forse perché sarebbe meglio lasciare chi gli altri parlassero di me, significherebbe che hai lasciato delle tracce di interesse e di stimolo, che è poi l’essenza del nostro lavoro. Pensando alle mostre che ricordo con più attenzione noto che sono tutte di natura diversa una dall’altra, questo perché fare una mostra lo intendo come rispondere ai dei quesiti, piuttosto che esporre il risultato di certezze acquisite. E i quesiti cambiano continuamente. Sono, se vogliamo, mostre processuali nella loro essenza, dove concepirle e svilupparle ci avvicina a risolvere delle proprie curiosità. Le mie mostre sono innanzitutto un fatto che trova origini personali, relative quindi e non assolute. Forse ciò viene dalla mia formazione di antropologo e non di storico dell’arte. L’arte l’ho acquisita osservando mia madre e mio padre che hanno sempre respirato arte e in “bottega” dall’arista Nunzio sin dall’età di 15 anni. Un lavoro sul campo se vogliamo usare una terminologia antropologica.La 34ª Biennale di Sao Paolo (2020) co-curata insieme anche a Jacopo Crivelli Visconti, esplorava la dimensione dell’opacità, di cosa avviene quando vibrano le corde del non definito, del suggerito, dell’accennato e del multiforme, rispetto alla dittatura del chiaro e manifesto. La ricchezza dell’opacità, di poter dire varie cose allo stesso tempo, così come nella poesia. Infatti la Biennale si intitolava “Faz Escouro mao canto”, un verso del poeta brasiliano Thiago de Melo, riferimento neanche troppo velato alla situazione socio politica che viveva all’epoca il paese.
Nel 2013, quando ero curatore presso il museo Boijmans van Beuningen di Rotterdam, ragionando sulla crescente diffusione delle immagini attraverso i social media, le gallerie iniziavano a inviare pdf delle proprie offerte, i siti avevano delle digital room… qualcosa stava cambiando nella fruizione delle opere. Mi chiesi cosa perdeva o guadagnava l’opera attraverso la sua rappresentazione, finii quindi per sviluppare uno studio nel rapporto tra fotografia e scultura, forse il medium che più soffre nella trasposizione dal tridimensionale al bidimensionale. Misi in connessione tre artisti che avevano lavorato su questo rapporto: Medardo Rosso, Costantin Brancusi e Man Ray. La mostra si intitolava “Framing Sculpture”. Ognuno aveva dato risalto all’importanza nel controllare l’immagine del proprio lavoro e come l’opera avrebbe tratto profitto da questa trasposizione, al di la delle logiche di diffusione/promozione. Sculture erano state associate a fotografie scattate dagli autori stessi (pratica comune per tutti e tre), offrendo al pubblico il confronto tra opera e rappresentazione. Un modo di parlare dell’attualità, esponendo opere di 50 o 100 anni precedenti.
Un altra mostra collaborativa è stato uno studio su Sol Lewitt. Date le sensibilità spaziali dell’opera di Lewitt, miste alla sua (apparente) rigidità concettuale, invitai Rem Koolhaas a ragionare insieme sulla (possibile) libertà che l’artista lasciava all’interno delle regole. L’umanesimo dietro Lewitt e dietro al rispetto della regola in generale. Lewitt si rivelò, innanzitutto ai nostri occhi, un artista sovversivo e non pertinente “ligio alle regole auto-imposte”, ne nacque la mostra “Sol Lewitt, Between the lines” alla Fondazione Carriero, 2017. Stessa cosa avvenne su Pino Pascali lo stesso anno, cercando di tirarlo fuori da una visione mediterranea che a mio avviso limitava la sua poetica piuttosto che darle ossigeno. Offrire nuove modalità di letture, facendo un confronto tra Pascali e lo sciamanesimo di origine africana. Per Pascali ogni mostra era una mise en scene teatrale e le sue opere venivano appunto inscenate in una drammaturgia, cosi come quando si inventa un genere performativo inedito usando le sue sculture come scenografie delle sue azioni, un po’ come le maschere africane che si attivano quando vengono indossate, soggette fortemente a una logica strutturalista, cosi come Pascali.
Fonte: Il Sole 24 Ore