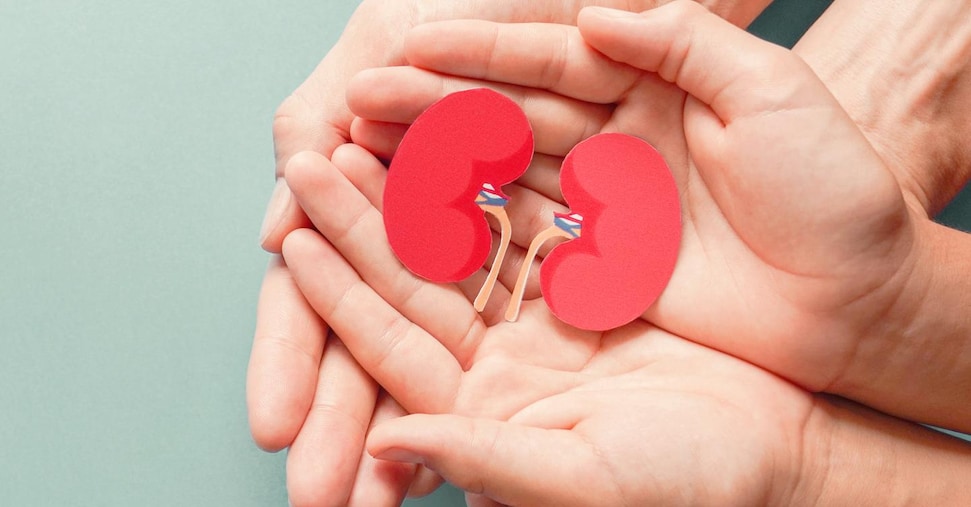Tra foglie e radici, misteri e sorprese nelle foreste del Sud
«Seduto sotto un albero a meditare mi vedevo immobile danzare con il tempo come un filo d’erba che si inchina alla brezza di maggio o alle sue intemperie, alla rugiada che si posa sui fiori quando s’annuncia l’autunno assomiglia…». Vengono in mente i primi versi della canzone Haiku di Franco Battiato quando si sale sul fianco della Serra delle Concazze, verso i vulcanetti Sartorius, prima meta di questo viaggio d’ottobre in alcune tra le foreste più emozionanti e meno conosciute del Sud Italia. Bisogna, del resto, partire proprio da Milo, il paese alle falde dell’Etna dove Battiato convinse anche l’amico Lucio Dalla ad acquistare una casa di laviche pietre accanto alla sua, dove il cantautore catanese è spirato nel 2021. Quassù, infatti, dopo un’anticamera frondosa tra bellissimi esemplari di pino laricio dal perenne e folto manto verde, iniziando a camminare lungo il sentiero che conduce alla bocca dei vulcanetti Sartorius, ci si trova circondati dalla fanteria imbelle e disarmante di betulle dalla corteccia bianca e dalla chioma che tra poco si farà dorata: i nodi tondeggianti apertisi nelle cortecce richiamano migliaia di occhi umani, il cui ricordo resta attaccato addosso anche quando si torna giù, nel giardino flamboyant dell’Eco Resort Donna Carmela, soggiornando nei suoi lodge immersi nella vegetazione esotica, affacciata sul vivaio.
In Puglia
Si rivolge alla piantagione di agrumi anche la sala colazione in stile orangerie di Torre Maizza, la bianca masseria del gruppo Rocco Forte immersa tra gli ulivi secolari di Savelletri, in provincia di Brindisi. Lasciate le sue nuove stanze, arredate con la consueta eleganza da Olga Polizzi, si può partire per un green bike tour alla volta di Martina Franca e della Riserva Bosco delle Pianelle, superando geometrie infinite di muretti a secco, cappelle votive pastorali, accompagnati dal belare delle pecore e dal profumo intensissimo dei ciclamini: risalente al XIV secolo, come Martina Franca, la foresta fu concessa alla popolazione dal suo fondatore Filippo I d’Angiò per ricavarne acqua e legna e allevare bestiame. Oggi le Pianelle sono selvagge eppure percorribili lungo i percorsi tracciati ad anello, sia a piedi che in bicicletta, che permetttono di immergersi tra querce virgiliane, lecci, fregni, roverelle e prugnoli che tappezzano anche le pareti interne della gravina. Seguendo le mulattiere si raggiunge il belvedere Pentima del Cavallo, dal quale si ammirano persino i monti del Pollino. Anche il Bosco Selva, alle spalle dei trulli di Alberobello, costituisce una frondosa sorpresa: in questi 45 ettari, infatti, avanzando tra esemplari di Quercus trojana, lecci e carpini, ci si può imbattere nella colorata ghiandaia e nell’upupa, e sul far della sera anche nell’assiolo e nel barbagianni che paiono intagliati nel legno dei vicini tronchi.
In Calabria
Spostandosi sulla costa tirrenica calabrese, nella faggeta di Pietrabianca, alle propaggini del Parco Nazionale del Pollino, si calpesta il tappeto giallo verde delle foglie sotto il cappuccio delle fitte capigliature in cima agli slanciati fusti: da qui passa anche il Sentiero Calabria Italia e si intrecciano i percorsi battuti dalla comunità valdese che nel borgo di Guardia Piemontese ha conservato cultura e tradizioni proprie, oltre ai vecchi telai in legno per la tessitura e gli abiti esposti nelle sale del locale museo. Proseguendo il viaggio costiero botanico sino a Lamezia Terme, si potrà soggiornare all’Agriturismo Costantino tra bambù, buganvillee e uliveti per poi, l’indomani, svegliati dalle voci dei bambini della scuola ospitata nel giardino, andare a salutare il platano millenario di Curinga.
In Basilicata
È sempre difficile lasciare il tufaceo Sasso Barisano di Matera, con le sue chiese affrescate e l’architettura sospesa fra l’archeologia e il design del Vetera Hotel, rifugio per amanti del minimalismo e della fantasia gastronomica. Ma è impossibile resistere anche al richiamo botanico ed energetico del Monte Croccia, con la sua riserva naturale-antropologica che attende il solstizio d’inverno, quando la luce passerà attraverso la spaccatura dei monoliti di arenaria tra le querce e i carpini, laddove nel IV secolo a.C. furono tracciate ben tre cinta di mura lunghe oltre due chilometri. A piedi, lungo il sentiero 704, si raggiunge il belvedere sulla distesa di alberi che veste le guglie delle Piccole Dolomiti Lucane.
Fonte: Il Sole 24 Ore