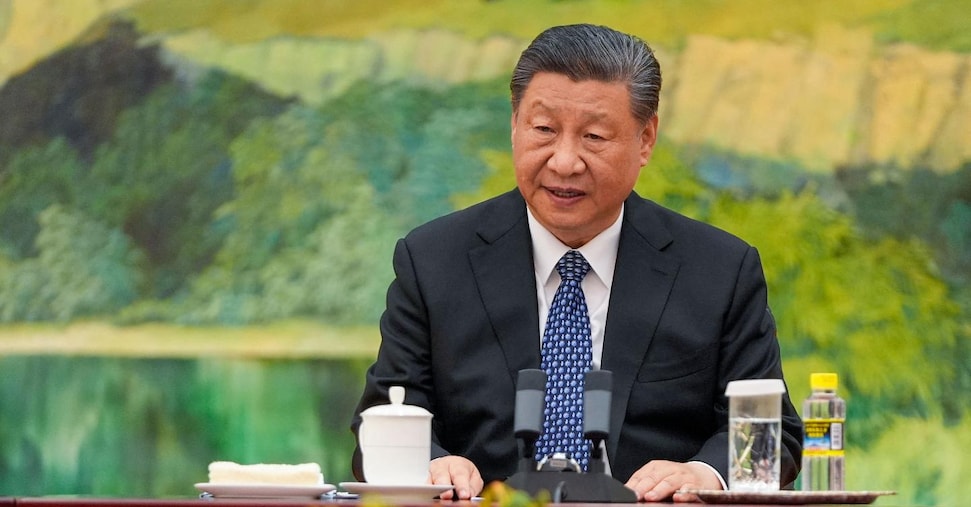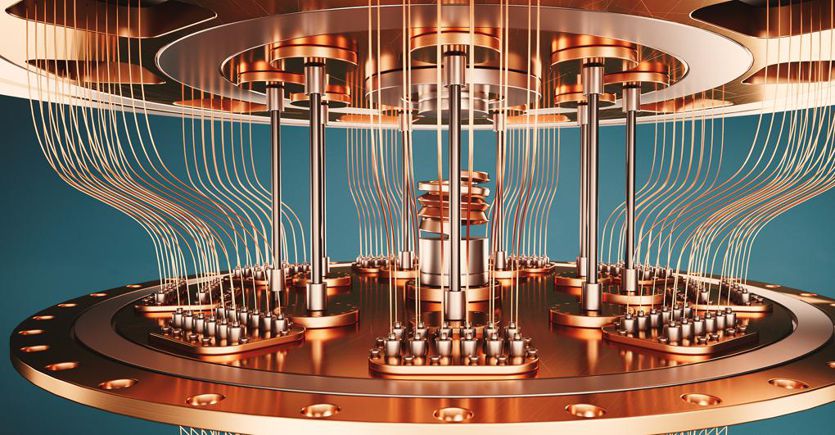Insubordinazione denigrare i capi su Facebook, sì al licenziamento
Via libera al licenziamento per insubordinazione del lavoratore che, sul suo profilo Facebook, denigra i capi. E il deterioramento dei rapporti non può essere invocato come giustificazione per la gogna sulla piazza social. La Cassazione (sentenza 27939) respinge il ricorso di un manager di Telecom che aveva perso il posto di lavoro per dei post che offendevano l’onore e la reputazione dei suoi superiori. Ad avviso dei giudici di merito, oltre alla diffamazione da valutare in sede penale, la giusta causa per il licenziamento era nell’insubordinazione legata all’attacco su Internet. Senza successo la difesa ricorda che la condotta censurata non poteva essere considerata insubordinazione. Diversa la conclusione della Cassazione, secondo la quale quest’ultima va intesa in senso più ampio rispetto alla lettura “tradizionale” che la collega solo al rifiuto del lavoratore di rispettare le disposizioni gerarchiche. Nell’insubordinazione rientra, infatti, «qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale».
L’efficienza legata all’autorevolezza dei superiori
La critica rivolta ai capi dunque, se va oltre i toni e la correttezza formale, è in grado di mettere a rischio l’organizzazione aziendale, dal momento che l’efficienza è legata all’autorevolezza di cui godono dirigenti e quadri intermedi. Un’immagine certamente pregiudicata se il lavoratore con toni ingiuriosi attribuisce ai capi «qualità manifestamente disonorevoli». Per i giudici l’invocata prova del «grave nocumento morale materiale» invocato dalla difesa è superflua. L’accertamento perché, nel caso esaminato, la “grave insubordinazione” era esplicitamente sanzionata dal Contratto collettivo nazionale applicabile alla categoria. Respinta anche la tesi della non utilizzabilità dei post su Facebook, in quanto diretti agli “amici”.
Inviolabili solo le chat “chiuse”
La Cassazione ricorda invece che il messaggio sul profilo social poteva essere legittimamente acquisito in quanto «non assistito da segretezza per la sua conoscibilità anche da terzi». Ferma restando l’esigenza, che nello specifico non c’è, di tutelare la libertà e la segretezza dei messaggi scambiati in una chat privata, destinati solo agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone e, «pertanto da considerare come la corrispondenza privata chiusa e inviolabile». A questo proposito i giudici di legittimità citano il precedente della conversazione su Facebook in una chat composta solo da iscritti ad uno stesso sindacato (sentenza 21965/2018)
Fonte: Il Sole 24 Ore