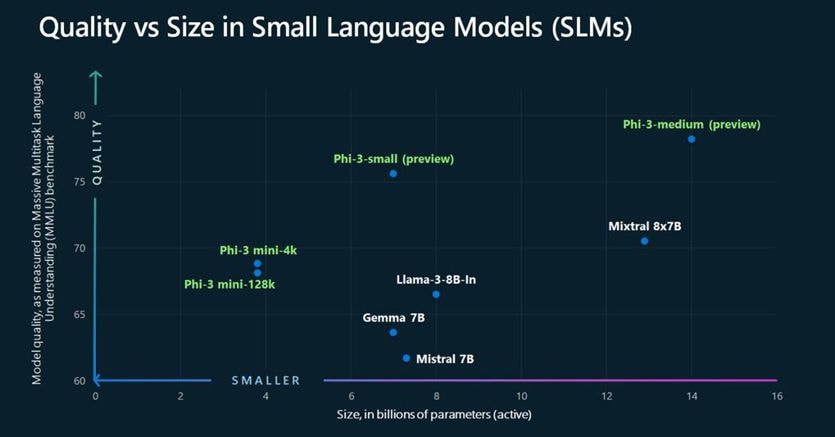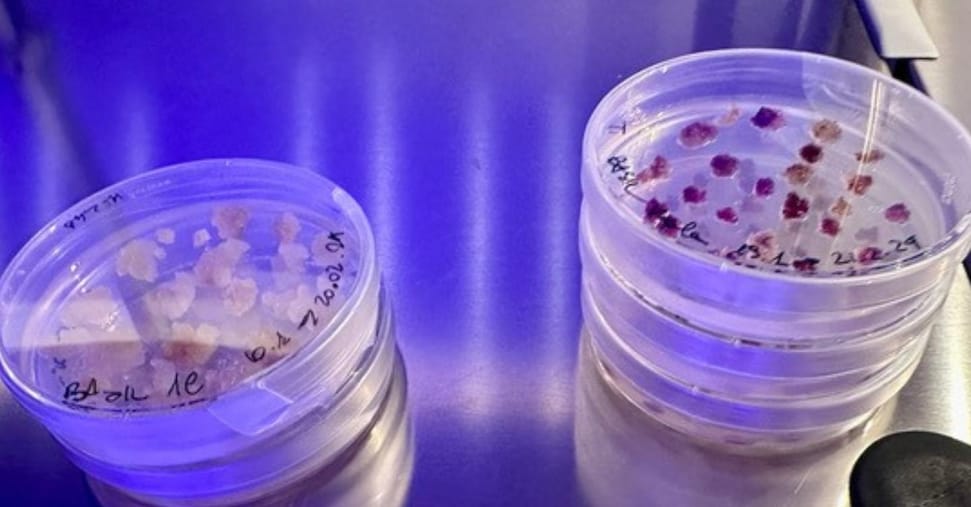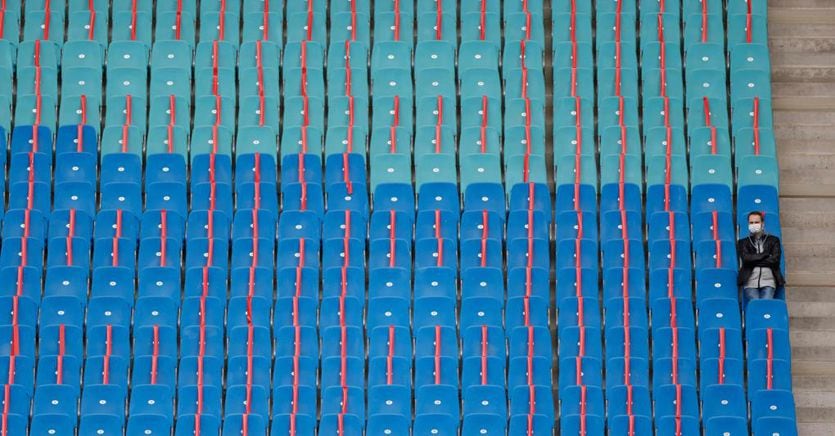
Mi sono fatto tutto da solo? Andiamo contro il mito del «self made man»
Alla fine di Broken, una raccolta di sei racconti pubblicata in Italia a luglio da HarperCollins, Don Winslow apre la sua pagina di ringraziamenti con queste parole: “Io non coltivo l’illusione di essere un uomo che si è fatto da solo, né che questo libro, come tutti gli altri miei lavori, sia lo sforzo di una sola persona”. Il richiamo alla cultura del self made man, così diffusa in Italia e nei Paesi anglosassoni, e alla retorica che la accompagna, è immediato.
Winslow, nonostante abbia fatto mille mestieri prima di diventare uno scrittore di culto, non si è mai occupato nella sua vita di management o di cultura di impresa, ma le sue parole suonano come pietre e sigillano uno statement che dovrebbe essere affisso sulle porte di ogni aula, più o meno magna, delle Business School, delle Corporate Academy e dei Centri di Formazione Permanente Aziendali. Una scrittrice italiana, Silvia Avallone, ha detto “che noi siamo le nostre storie, che ciascun individuo non è quel che si vede o che si pensa di vedere, ma la storia che lo ha reso tale” (domenica 13 settembre, Triennale di Milano, Il Tempo delle Donne 2020, incontro sul tema “Rigeneriamo una parola chiave: il rispetto”).
Loading…
Se è vero che “nessun uomo è un’isola”, che ogni uomo e ogni donna sono la loro storia e che ogni storia è una storia di incontri, di relazioni e di interazioni, allora la retorica del self made man – non a caso man e non woman – andrebbe abbandonata e dovrebbe uscire definitivamente dalla letteratura e dalla narrazione di qualsiasi percorso formativo, dentro e fuori dalle aziende. E andrebbe altresì bandita questa idea bislacca, fasulla e dannosa perché illusoria, che un individuo debba concentrarsi solo su stesso per combinare qualcosa di buono nella vita; o possa essere riconoscente solo a se stesso, per quanto di buono è già riuscito a fare nella sua sfera professionale o personale.
Si potrebbe obiettare che questa narrazione e questa retorica sono datate e, ormai, inascoltate e desuete. In molte aziende si predicano da anni – e talvolta si praticano – forme di intelligenza collettiva, si parla di leadership diffusa, si costituiscono leadership community, si generano contesti di collaborative learning, si invitano testimonial ed esperti a intervenire su questi temi, si mette in rilievo nei modelli di competenze manageriali la capacità di cooperare (vedasi ad esempio il testo Six Simple Rules di Y. Morieux).
Però, nonostante tutto, resta spesso l’intima sensazione che tutto – le sorti dell’azienda, i risultati del quarter, il lancio di un prodotto, il futuro professionale di una persona – sia nelle mani di pochi singoli e selezionati individui (tipo Avengers) che, grazie alle loro forze, hanno compiuto o potranno compiere imprese straordinarie. Talvolta, addirittura, nelle mani di uno solo. Con la duplice conseguenza di smettere di pensare di poter contribuire in modo sostanziale alle sorti dell’azienda e di poter essere artefici del proprio destino; e, d’altra parte, di alimentare, in genere fino a una certa età, la speranza di poter diventare una persona con una storia da poter raccontare (non solo a eventuali nipoti).
Fonte: Il Sole 24 Ore